Chi me l’ha fatto fare? Un blog!
Forse la noia.Forse la voglia di parlare senza essere interrotta.O forse (più probabile) il desiderio di condividere quello che scrivo, dipingo, penso… e sogno.


Il nostro viaggio inizia qui, nel cuore di Artemisia. Scopri uno spazio dove le parole dipingono emozioni e i pensieri prendono forma. Non vendo nulla, non cerco di impressionare. Scrivo per condividere, per riflettere, per fare compagnia. Sono felice di averti qui, parte della mia storia.
23 giu 2025 11:48
Forse la noia.Forse la voglia di parlare senza essere interrotta.O forse (più probabile) il desiderio di condividere quello che scrivo, dipingo, penso… e sogno.
23 giu 2025 11:37
Ho versato un bicchiere di vino rosso.Non per fare la sofisticata ma per sciogliere quei freni invisibiliche spesso ci tengono le parole in ostaggio.

Mi chiamo Artemisia, come un fiore… o forse come un colore.
Sono una donna curiosa, sensibile, a volte ironica, spesso riflessiva.
Nel corso della vita ho indossato tanti ruoli: madre, amica, compagna, artista, ascoltatrice.
E oggi, con più tempo tra le mani e un cuore pieno di storie, mi concedo il lusso di raccontare.
Amo scrivere e dipingere, soprattutto ad acquarello:
mi affascinano le sfumature, i passaggi delicati,
le cose che non hanno bisogno di urlare per farsi notare.
Sono una nonna fortunata, anche di due meravigliosi gemelli e adoro creare piccoli momenti di bellezza, che siano una chiacchierata, un fiore in un vaso, o un pensiero da condividere.
In questo blog non troverai verità assolute né ricette per la felicità.
Troverai me:
con le mie parole, i miei silenzi, e le emozioni che ho deciso, finalmente, di lasciare respirare.
Se ti va, resta un po’.
Metti su l’acqua per il tè (o apri una bottiglia di vino 🍷),
e sfoglia insieme a me questo quaderno di vita.
Soffro di un’eccessiva empatia. Non è un dono magico, non è qualcosa che si sceglie: è allenamento. Allenamento al dolore.
Chi ha vissuto traumi, relazioni tossiche, delusioni profonde… sviluppa un radar invisibile.
Non si vede, ma funziona benissimo. Capta microespressioni, cambi di tono, silenzi carichi di significati. E lo fa senza pensarci, senza sforzo, come un riflesso.
Perché una parte di noi, quella che ha imparato a difendersi, è ancora in allerta. E osserva tutto. Non per giudicare, ma per proteggersi. Perché chi ha sofferto una volta, non vuole soffrire ancora.
Questa empatia a volte pesa. Ti fa sentire tutto, anche ciò che non ti appartiene. Ma è anche una forza. È la capacità di comprendere davvero, di accogliere, di esserci per gli altri… anche nel silenzio.
Io questa forza ce l’ho.
E imparo ogni giorno ad usarla con cura. Anche verso me stessa.


Non ho molte amiche.E, forse è strano dirlo, ma ognuna di loro è l’opposto di me. È proprio per questo che le adoro.
Con loro non cerco uno specchio, ma un confronto.
Costruttivo, sincero, a volte spiazzante. Mi mostrano altri modi di essere, di pensare, di vivere.
A volte le invidio, sì, in senso buono, perché riescono a fare o dire cose che io non riesco.
Sono più decise, più leggere, più spavalde… o semplicemente diverse. E questa diversità mi arricchisce.
Mi completa. Mi aiuta a capire dove magari sbaglio, dove posso migliorare. Mi dà il coraggio di scegliere, di agire, quando io resterei ferma a pensare.
Sono anche molto diverse tra loro.
Ognuna vive su un pianeta tutto suo.
E io viaggio tra questi mondi, raccogliendo sorrisi, idee, conforto. A volte ricevo aiuto anche da quei “satelliti” che orbitano attorno a loro: amici, parenti, persone preziose che entrano nella mia vita attraverso le loro.
La nostra forza è il rispetto
La nostra forza non sta nel vederci sempre, né nel dirci tutto.
Non sta nell’essere simili, né nel pensarla allo stesso modo.
La nostra forza è il rispetto.
Rispetto per ciò che siamo, con i nostri pregi, le nostre paure, le nostre stranezze.
Rispetto per i nostri spazi: quelli fisici e quelli dell’anima.
Perché sappiamo che a volte il silenzio non è distanza, è bisogno.
Che un messaggio non risposto subito non è disamore, ma vita che accade.
Che ognuna di noi ha un ritmo diverso… e va bene così.
Ci lasciamo libere.
Libere di essere stanche, di avere giornate no, di sparire un po’ per poi tornare.
Senza pretese, senza sensi di colpa.
Sappiamo che l’amicizia vera non si misura con la quantità di tempo trascorso insieme,
ma con la qualità dell’ascolto, della presenza, del cuore.
E allora sì, è il rispetto che ci tiene unite.
Come un filo invisibile che non stringe, ma lega.
Un legame che non si impone, ma accoglie.
Ci conosciamo sin dalle elementari. Una vita intera, fatta di giochi, confidenze, risate, silenzi, lacrime e complicità. Donatella è quella presenza costante che non ha mai avuto bisogno di parole per farsi sentire vicina.
È la sorella che la vita mi ha regalato, la testimone silenziosa della mia crescita, la compagna di avventure (e disavventure), l'Amica con la A maiuscola.
È Ariete, e questo dice già molto. Ha dentro di sé una forza naturale, una determinazione che la rende una vera e propria forza della natura. A volte la guardo e penso a Leonardo da Vinci: tutto ciò che le frulla per la testa, in un modo o nell’altro, prende forma tra le sue mani. È un’artista poliedrica, creativa, ingegnosa. Una leader nata.
Organizza la sua vita (e anche quella degli altri) con precisione millimetrica, è sempre un passo avanti. Perfetta nel lavoro, qualunque esso sia.
Il contrario di me, che vivo un po’ alla giornata, e forse proprio per questo ci completiamo.
Sotto quella corazza da donna forte, io so bene quante fragilità nasconde. Come madre, come sorella, come moglie… Ho imparato a vederle, anche quando non si dicono. E la rispetto profondamente anche per questo.
Di recente è diventata nonna, e mi incuriosisce questo suo nuovo ruolo. Soprattutto pensando a quando, in passato, si lasciava sfuggire osservazioni amare sul futuro, arrivando a dire che non ha senso mettere al mondo figli in un mondo così sbagliato. Eppure eccola lì, oggi, a guardare negli occhi una nuova vita, e a riflettere – forse – sul senso profondo di tutto.

Donatella è una persona fortunata, ma gran parte di quella fortuna se l’è costruita da sola, passo dopo passo, senza l’appoggio dei genitori, che se ne sono andati troppo presto.
E io sono fortunata ad averla ancora accanto.
Ci sono altre amiche nella mia vita, speciali a modo loro, che racconterò in seguito. Provengono da altri emisferi, altri mondi, altre sfumature dell’anima… ma tutte, come Donatella, hanno lasciato un’impronta nel mio cuore.
Nella mia vita ho conosciuto l’amore in tante forme.
A volte è stato un lampo, improvviso e accecante. Altre volte un fuoco più lento, più calmo, ma non meno intenso.
Ma la persona che ho amato di più è stata mio marito, Pietro.
La nostra è stata una storia lunga quasi quarant’anni, fatta di alti e bassi, com’è normale che sia, ma soprattutto di un’intesa profonda, rara, che ancora oggi mi sorprende quando ci ripenso.
Ci siamo conosciuti non da giovanissimi, eravamo colleghi di lavoro. Io uscivo da una separazione, con un figlio piccolo, e lui è entrato nella mia vita come un compagno gentile, rispettoso, paziente.
All’inizio non è stato facile: negli anni ’80 non tutti accettavano facilmente una nuova unione, una “famiglia ricostruita”. Ma noi abbiamo lottato. Insieme.
Eravamo amici, compagni, soci, colleghi, complici.
Condividevamo valori, sogni, difficoltà, progetti.
Quando ci siamo sposati, dopo anni di attesa, di desiderio, di costruzione, è stato davvero un punto d’arrivo. Non avevamo convissuto prima, e forse per questo quel giorno è stato magico, quasi fiabesco. Il coronamento di un amore maturo, scelto, voluto.

Pietro è scomparso quattro anni fa. E non passa giorno in cui io non lo porti dentro di me, in un gesto, in un ricordo, in un pensiero.
Eppure, nonostante la sua assenza, sento che la fiaccola dell’amore dentro di me è ancora accesa.
Perché l’amore non è mai qualcosa che finisce. È un’energia viva, inesauribile. È quella parte di noi che continua a brillare, anche quando la vita cambia, anche quando restiamo soli.
E sì, io posso ancora amare.
Perché l’amore vero, quello che ho vissuto, non mi ha chiuso il cuore. Me lo ha spalancato.
E questa, per me, è una delle eredità più belle che Pietro mi ha lasciato.
Caro Pietro,
è difficile scriverti senza sentire un nodo alla gola.
Mi manca la tua voce, il tuo modo di guardarmi senza parlare, quel nostro linguaggio muto fatto di sguardi, di silenzi che dicevano tutto.
Sono passati quattro anni.
E a volte mi sembra ieri, a volte un’altra vita. Ma quello che provo per te non ha tempo.
Non si è spento. Non si è consumato.
È lì, dentro di me, come un filo invisibile che ancora mi lega a te.
La nostra è stata una storia vera.
Con le sue salite e le sue curve, ma sempre fianco a fianco.
Siamo stati amici, complici, colleghi, amanti. Abbiamo costruito tanto, senza clamori, ma con tenacia. Ci siamo presi per mano quando il mondo fuori ci giudicava, e non ci siamo mai lasciati.
Il giorno del nostro matrimonio… che gioia.
Io, tu, un sogno che diventava realtà. Forse proprio perché non era scontato, perché ci eravamo già guadagnati ogni piccola felicità.
Non abbiamo convissuto prima, e forse per questo ogni gesto, ogni abitudine insieme era una scoperta, un regalo.
Oggi, quando mi fermo a pensare a noi, sento un misto di gratitudine e malinconia.
Mi manchi tanto.
Eppure ti sento vicino. In certe giornate di sole, in un odore di caffè al mattino, in un consiglio che mi pare ancora di sentire uscire dalla tua voce.
Sai una cosa, Pietro?
La fiaccola dell’amore, quella che abbiamo acceso insieme… non si è mai spenta.
Anche adesso, quando il cuore si stringe, io so che è lì. E so che tu ci sei. Non nel passato, ma in una parte profonda di me.
Con tutto l’amore che posso,
C’è un momento, a volte silenzioso, a volte doloroso, in cui in un matrimonio si smette di essere amanti.
Non succede all’improvviso. È più come una nebbia lenta che cala. Un giorno non ti accorgi più dello sguardo dell’altro. Non cerchi più la sua mano. E le parole diventano pratiche, comunicazione di servizio.
Essere amanti non è solo desiderarsi. È stupirsi ancora, scegliersi con gioia, restare curiosi l’uno dell’altro.
Nel tempo, però, arriva la fatica, la routine, la vita. I figli, il lavoro, i pensieri. E si rischia di diventare compagni di squadra, bravi organizzatori, forse anche buoni genitori… ma non più amanti.
E allora?
Allora si può scegliere.
Si può decidere di ritrovarsi. Di parlarsi. Di fare spazio. Di rimettere in circolo il desiderio, che a volte non è passione, ma solo voglia di essere visti.
Oppure, con onestà, si può prendere atto che l’amore ha cambiato forma. Che forse si è trasformato in affetto, stima, ma non più scintilla.
Non c’è un’unica verità.
Ma credo che riconoscere quel momento, quando si smette di essere amanti, sia un atto di coraggio. E anche di amore, verso se stessi e verso l’altro.
Dopo aver parlato di amore e amicizia, sento il bisogno di aprire una finestra sul mio mondo colorato.
Disegnare non è sempre stato parte di me.
Fino alla quarta elementare ero l’assoluta negazione. Poi, in quinta, arrivò il maestro Tognetti. Lui sì che era un artista vero: maestro e pittore.
Un giorno ci chiese di disegnare un albero del giardino della scuola. Io, con tutta la fantasia di una bambina svagata, disegnai un abete… senza neanche affacciarmi alla finestra.
Il maestro si avvicinò, guardò il mio disegno e disse:
«È molto bello… ora mostrami quale albero hai disegnato.»
Silenzio. L’abete non c’era.
E lui, con un sorriso che non ho mai dimenticato, mi disse:
«Vedi, non deve essere perfetto. Ma deve essere vero. Osservalo. Anche se è storto, anche se è spelacchiato. Ha qualcosa da raccontare. Guarda… e non limitarti a vedere.»
E così è iniziato tutto.
Da quel giorno ho cominciato a guardare. Gli alberi, le persone, la vita.
E spesso li dipingo.
Ma questo lo racconto nel prossimo post…

Ci sono semi invisibili, che si piantano nei cuori dei bambini quando metti loro in mano un pennello, un foglio bianco, una melodia. Sono semi di bellezza, di stupore, di emozione.
Cresceranno in occhi capaci di veder l’armonia nei colori e nei gesti gentili.
L’arte non è solo disegno, è un modo per imparare a sentire, a raccontare ciò che le parole non dicono, a guardare il mondo con occhi nuovi.
Aiutiamo i bambini a creare, non per farne artisti, ma per farne anime attente, cuori aperti, menti libere.
Perché chi cresce vicino alla bellezza, la cercherà sempre…e forse saprà anche regalarla
La mia parte estetica, il mio amore per l’arte e per la bellezza mi accompagnano ogni giorno.
Dall’apparecchiare la tavola (con i colori tassativamente coordinati!) a come mi vesto, a come scelgo anche i dettagli più piccoli.
Non mi sento un’artista ma di certo una persona appassionata, che trova gioia e gratificazione in tutto ciò che è curato, armonioso, bello. E forse è per questo che credo tanto nell’importanza di educare al bello fin da piccoli: perché il bello fa bene. Sempre.
✒️ I miei primi passi... a puntini!
I miei primi lavori più interessanti li ho realizzati usando la china, con una tecnica chiamata puntinata.
Un nome curioso, vero?
Ma dietro quei “puntini puntini puntini” c’è un mondo di precisione, cura e silenzio.
La tecnica puntinata consiste proprio in questo:
creare forme, volumi e sfumature utilizzando solo ed esclusivamente puntini realizzati con la punta sottilissima di una penna a china o un pennino.
Niente linee, niente tratti lunghi. Solo una pazienza certosina,
e una danza di punti neri che piano piano, uno accanto all’altro, formano ombre, luci e profondità. Più fitti i puntini, più scura l’area. Più distanziati, più chiara.
Una magia tutta in bianco e nero.
Ogni disegno richiede tempo e silenzio, ma quando il soggetto comincia a emergere dalla carta… che soddisfazione!
Questa tecnica mi ha insegnato tanto: la lentezza, la precisione,
il rispetto dei tempi dell’arte.
E anche un po’ di sana ostinazione!
Qui si sogna (con le mani sporche) Tra schizzi, sbagli e magia
C’è un posto, nella mia casa, che non è solo una scrivania, un tavolo o una stanza.
È la mia postazione creativa:
uno spazio tutto mio, dove il tempo rallenta e la realtà resta fuori dalla porta.
Appena mi siedo lì, entro in una specie di mondo parallelo:
silenzioso, colorato, profondo.
Lì dentro ci sono i miei pensieri, le emozioni che non ho ancora detto, i ricordi che bussano piano e tutto ciò che non riesco a esprimere a parole…ma che con una pennellata, un tratto, una macchia di colore diventa vita sulla carta.
Non contiene solo arte, ma anche un po’ di me stessa.
Ogni oggetto ha una storia: una matita consumata, un barattolo di pennelli in ordine sparso, fogli sparpagliati con idee a metà, un quaderno con frasi appuntate in fretta.
È uno spazio sacro, ma semplice. Niente di perfetto, niente di elegante.
Ma mio, profondamente.
Un luogo dove non devo spiegare nulla, dove posso
sbagliare, ricominciare, sperimentare, e anche solo… stare.
È lì che nascono le mie piccole creazioni, ma soprattutto è lì che mi ritrovo.
Con i miei colori, i miei silenzi e le mie meravigliose incostanze.






Perché dipingere con l'acquarello è così bello?
Perché è come respirare a colori.
Perché l’acqua non si comanda, si accompagna.
Perché ogni macchia è una sorpresa,
ogni sfumatura è un'emozione che scivola sulla carta.
L’acquarello non si impone: suggerisce.
Non grida: sussurra.
È il dialogo tra l’intenzione e l’imprevisto,
tra la mano e il cuore.


La pittura ad olio è spesso definita una delle tecniche più “permissive” e flessibili, soprattutto per chi desidera avere tempo per riflettere, correggere e trasformare il proprio lavoro.
A differenza dell’acquerello o dell’acrilico, l’olio asciuga molto lentamente, il che permette di:
Modellare i dettagli anche dopo ore o giorni;
Sfumare con precisione, senza lasciare segni netti;
Aggiungere e togliere colore con facilità (anche grattando via o ripassando tonalità più chiare o scure);
Sovrapporre strati, lavorando "a velature" per effetti di profondità e luce.
Inoltre, l’olio ha una texture ricca e corposa, che consente sia lavorazioni morbide e sfumate, sia tratti decisi con pennellate materiche. È ideale per chi ama un approccio lento, meditativo, quasi “scultoreo” alla pittura.
In sintesi:
L’olio ti accompagna, non ti mette fretta. È una tecnica che si presta alla trasformazione, alla riflessione… e anche all’errore. Per questo, per molti, è la più “facile”: perché ti permette di crescere con lei, passo dopo passo.



A volte mi sorprendo a pensare ai grandi artisti.
Leonardo, Caravaggio… o anche Ligabue, così ingenuo eppure così profondo.
Mi domando se il vero dono dell’arte, in tutte le sue forme, non sia una prova tangibile dell’anima. Perché cos’è l’arte, se non una forza invisibile che prende forma attraverso le mani, gli occhi, la voce, il colore?
È impalpabile come un sogno, eppure ha una forza dirompente. Ti attraversa, ti cambia, ti smuove.È energia. È silenzio. È verità.
Forse è davvero un frammento di energia cosmica, che ognuno riceve e sviluppa a modo suo. Chi lo trasforma in pittura, chi in musica, chi in parole o in gesti d’amore. Ma in fondo… è sempre l’anima che parla.
Ed è proprio per questo che, ogni volta che dipingo, cerco quel momento in cui il pennello non segue più la mia mano, ma qualcosa di più grande, che non so spiegare… e che riconosco solo quando sento: “Ecco, questa sono io.”
Perché nel mio caos creativo, abita l’anima.
E ogni colore, ogni linea, ogni sfumatura… è solo un modo per lasciarla parlare.
Se anche tu senti l’arte come un linguaggio dell’anima, lascia un commento o condividi il tuo pensiero.
A dire il vero, non era previsto che io finissi al liceo artistico.
Mio padre aveva altri piani: mi iscrisse a ragioneria.
Probabilmente pensava che i numeri fossero più affidabili dei colori.
Ma il mio corpo non era d’accordo.
Dopo soli tre mesi, cominciò una vera e propria reazione di rigetto,
come quando cercano di sostituirti il cuore… con uno di plastica.
La sera mi veniva la febbre, senza motivo apparente.
Fino a quando il medico di famiglia, con un intuito da artista anche lui, disse semplicemente:
“Signori, non è malata. Deve solo cambiare scuola.”
E così è stato. Dal grigio dei registri al profumo della trementina, dalla rigidità dei conti alla libertà di una linea incerta ma viva.
E tutto ha cominciato a respirare.
Negli anni ’70, il liceo artistico di Lucca era più simile a un'accademia che a una scuola.
Non c’erano banchi in fila e lezioni frontali: c’erano cavalletti, odore di tempera, gessetti sulle mani e pareti piene di schizzi.
Eravamo un po’ tutti figli dei fiori, con la testa tra le nuvole e i sogni tra le dita.
Le giornate si alternavano tra disegno dal vero, tecniche pittoriche, scultura, incisione, e a volte… un po’ di cultura generale.
Lingua italiana? Un po’. Matematica? Il minimo indispensabile. Inglese? Un mistero esotico.
Ma se prendevi un 4 in storia o in fisica… nessuno gridava allo scandalo.
L’importante era creare, sperimentare, sbagliare e ritentare.
Era normale non seguire le regole: l’arte ti educava a pensare da solo.
Ricordo professori appassionati, eccentrici, a volte geniali, a volte un po matti. Ricordo mani sporche, cuori pieni, silenzi densi e chiacchiere infinite tra un tratto a china e una canzone dei Pink Floyd.
Non avevamo internet, ma avevamo tempo e spazi per respirare. E in quel tempo lento, l’arte diventava parte di noi. Non era un hobby.
Era un modo di stare al mondo.
Oggi i licei sono pieni di orari serrati, interrogazioni continue, pagelle elettroniche e voti che pesano.
A volte penso che l’arte, in certe scuole, sia diventata una materia in più e non più una materia dell’anima.
Io, invece, continuo a cercarla lì: nella lentezza, nella libertà, nel disordine creativo che profuma ancora di giovinezza e carta ruvida.
E quando dipingo, risento quella voce lontana che mi dice: “Vai, prova. Non devi fare bene… devi fare vero.”
Hai vissuto anche tu un’epoca scolastica “diversa”?
Sei cresciuto in un liceo, in un’officina, o nella vita vera?
Mi piacerebbe sapere dove hai incontrato per la prima volta l’arte vera, quella che ti ha cambiato.
Scrivilo nei commenti 🌼
Io c’ero. E ci stavo dentro fino al collo.
Era la mia adolescenza: quella fase della vita che, allora, non era considerata una malattia, ma nemmeno una cosa seria.
Una roba da tenere d’occhio, sì… ma senza troppe paranoie. lo psicologo non era contemplato.
Erano gli anni dei primi amori, degli scioperi scolastici "rivoluzionari" (a volte solo per il gusto di stare fuori), e della voglia di stare insieme, quella che, diciamolo, non è mai cambiata.
Andavo in giro in motorino, senza cellulare, senza localizzazioni, e bastava pochissimo per sparire dai radar.
Il trucco? Avere almeno tre amiche fidate, che nel caso di una telefonata da casa rispondessero tranquille:
“È appena andata via!” Geniale. E assolutamente innocente.
Perché non c’era niente di male da fare, era solo il gusto di essere libere, per due ore, senza dover rendere conto a nessuno.
E quella libertà… non aveva prezzo.
C’era quasi sempre un ragazzino di mezzo.
Un bacio sulle mura, uno sguardo al cinema, una lettera lasciata in tasca o una stretta di mano troppo lunga.
Sentimenti veloci, che svanivano in un giorno. Ma erano importanti: erano solo un allenamento a qualcosa di più grande, che sapevamo che sarebbe arrivato…prima o poi.
L’amore vero era lontano, ma intanto imparavamo a sentire il cuore che batteva.
E anche quello… era già vita.

Oggi guardo i ragazzi, sempre connessi, sempre tracciabili, sempre impegnati. E mi chiedo se sappiano ancora cosa vuol dire
sparire per un pomeriggio intero con un’amica, solo per stare a ridere e guardare il cielo.
Io lo so.
E nel mio modo di dipingere, di scrivere, di ricordare…
cerco ancora quella libertà lì.
Qual era il tuo posto segreto? La tua scusa preferita? Il tuo primo bacio?
Raccontamelo nei commenti o… tienilo nel cuore.
Tanto certe cose non passano mai. 🌻

La mia adolescenza è arrivata tardi. O meglio, sono arrivata tardi io. Non avevo alcuna fretta di crescere, di diventare “signorina”, come si diceva allora. Ero troppo impegnata a vivere un’infanzia che sembrava non voler finire mai – e per fortuna.
Mentre le mie coetanee scoprivano trucchi e pettinature da imitare sulle riviste, io giocavo alla guerra con i ragazzini del quartiere. Eravamo una banda disordinata e urlante, con regole tutte nostre e nemici immaginari da combattere. Uno dei nostri “avversari” era un certo Mario C., il vicino di casa, uno di quelli sempre pronti a metterci i bastoni tra le ruote… o almeno così ci sembrava.
Ricordo un pomeriggio d’estate, sole alto e ginocchia già piene di croste, in cui decidemmo di “invadere” il cortile di Mario. Durante la missione – ovviamente segreta – mi toccò scavalcare un filo spinato. Un filo vero. Il risultato? Una bella ferita al ginocchio, profonda, e il sangue che sgorgava a fiotti. Ma il mio primo pensiero non fu il dolore. No. La mia preoccupazione più grande era tornare a casa senza farmi scoprire, perché altrimenti mia madre mi avrebbe messa in punizione e addio giochi per una settimana!
Così mi inventai una storia frettolosa, cercai di pulirmi con un fazzoletto stropicciato e tornai a casa cercando di camminare con nonchalance, come se nulla fosse. Ma ovviamente mia madre se ne accorse subito. Aveva quel sesto senso micidiale che solo le madri possiedono. Dopo un bel rimprovero e qualche punto di sutura, finii comunque in castigo. Ma ne valse la pena: ero un soldato con onore ferito in battaglia.
Fu così, tra guerre finte, ginocchia sbucciate e sogni di gloria, che attraversai l’adolescenza senza accorgermene. I primi turbamenti, le prime emozioni nuove, arrivarono dopo, quando ormai la mia infanzia aveva già lasciato il segno – letteralmente – sulla mia pelle.
E se oggi guardo quella cicatrice sul ginocchio, sorrido. È una piccola medaglia al valore, la prova che la mia adolescenza non è stata fatta di smalti e diari segreti, ma di libertà, risate e un pizzico di incoscienza. Quella che serve, a volte, per diventare grandi… ma con leggerezza.
Mentre scrivo e ripercorro i passi della mia vita, mi accorgo che sto facendo molto più di un semplice racconto. In fondo, c'è un desiderio che si fa sempre più chiaro: lasciare una traccia di me.
Vorrei che i miei nipoti, che non vedo spesso, potessero un giorno leggere queste pagine e scoprire chi era davvero la loro nonna. Non solo quello che ho fatto, ma come ho pensato, cosa ho sentito, come ho amato e anche come ho sbagliato.
E forse anche i miei figli, leggendo, scopriranno qualcosa in più su di me. Perché, ammettiamolo, spesso nella vita quotidiana si corre, si parla poco, e si dà per scontato di conoscersi.
Questo blog è un modo per raccontarmi con calma, senza filtri, a chi vorrà ascoltare. Anche tra tanti anni.
Sono nata in Sardegna, la mia meravigliosa terra. Un’isola che porto addosso come un profumo salmastro e selvatico, con la sua luce accecante, le pietre antiche, il vento che non si ferma mai e quel silenzio profondo che sa parlare.
Lì affondano le mie radici. Forti, ruvide e tenaci. Come i sardi.
I miei genitori erano entrambi sardi.
Mio padre, ex maresciallo di marina, portava in casa un senso dell’ordine e della disciplina che si sentiva ovunque: negli orari, nel tono della voce, nelle regole non dette ma ben chiare. Non era un uomo espansivo, ma sapeva esserci. A modo suo.
Mia madre, più morbida ma non meno determinata, era il cuore della casa. Le sue mani erano sempre in movimento e i suoi occhi vedevano tutto, anche quello che cercavamo di nascondere.


Sono la più grande di tre figli, e ho due fratelli maschi: Stefano e Giorgio.
Essere la primogenita è stato un po’ come fare da sentiero nella boscaglia: aprire la strada, affrontare per prima, osservare gli altri che camminano dietro. Ma è stato anche un grande allenamento al sentire profondo, all’ascolto, alla cura.
Il paese in cui sono nata si chiama Guspini. Un angolo della Sardegna che oggi vive nei miei ricordi come un luogo sacro.
E lì, proprio lì, ho vissuto tutte le estati della mia giovinezza. I primi venticinque anni li ho passati a respirare il mare e a farmi spettinare dal maestrale.
Ogni estate è stata speciale, tutte, nessuna esclusa.
Ancora oggi, quando torno, sento un nodo in gola e una felicità che mi sorprende. Come se i miei piedi sapessero da soli dove andare.
Il mare della mia infanzia non è cambiato: sa ancora accogliermi come una madre, o forse come una parte di me che non se n’è mai andata.
Ecco le mie radici.
Radici salate, forti e piene d’amore.
Di me da piccola ci sarebbero mille aneddoti da raccontare, ma ce n’è uno che, ogni volta che lo ricordo, mi fa sorridere e scuotere la testa.
Già da bambina avevo dentro una specie di zaino invisibile: fatto di coraggio, indipendenza, e una fiducia incrollabile in me stessa. Me ne andavo da sola, curiosa e tranquilla, senza paura. Non avevo bisogno di essere accompagnata: il mondo mi chiamava, e io rispondevo.
Un giorno, dopo una piccola marachella (non ricordo nemmeno bene quale fosse – forse una bugia, o un pasticcio combinato con troppa fantasia), mio padre, serio e burbero come solo un maresciallo di marina sa essere, mi guardò e disse per scherzo:
“Se fai così, ti mando via di casa!”
Quello che lui non sapeva, è che io lo prendevo sempre sul serio.
E così, senza una lacrima, senza rabbia, ma con una calma assoluta, mi incamminai per la strada.
Non sapevo bene dove andare, ma sapevo che me la sarei cavata. Dopo tutto, avevo lo zaino invisibile.
Mi rifugiai a casa di una vicina, una signora gentile che conoscevo bene, e con grande naturalezza le dissi che avrei passato lì la notte.
Quando mio padre mi ritrovò lì, non so se fu più spaventato o sorpreso.
Di sicuro capì due cose:
Che avevo preso alla lettera ogni sua parola.
Che aveva una figlia tosta.
Quella volta non fui punita. Forse perché avevo già dato prova sufficiente del mio carattere.
Forse perché, in fondo, nessuno può mandare via una bambina che ha già deciso dove andare.

Fin da piccola ho avuto uno spirito di indipendenza che non mi ha mai lasciata.
È come una compagna invisibile che cammina accanto a me, a volte leggera come una brezza, altre volte forte come un vento impetuoso.
Essere indipendenti significa avere la forza di scegliere da sola la propria strada, di non dipendere dal giudizio degli altri, di affrontare la vita con il proprio passo.
Per una donna, questa libertà è un regalo prezioso. Ti rende capace di amare senza perderti, di dire “no” quando serve, di custodire dentro di te la tua voce più autentica.
Ma non è sempre facile.
Lo spirito di indipendenza, a volte, può far sentire sola. Può creare distanze, perché chi ti vuole bene può faticare a capire perché non ti pieghi o perché non accetti compromessi facili.
Può sembrare durezza, o disobbedienza, o “testardaggine”.
Ma in realtà è solo la fedeltà a una verità interna che chiede di essere ascoltata.


Ho sempre fatto il lavoro che mi piaceva, anche quando questo significava fare scelte più dure, più scomode, più coraggiose.
Ricordo quando ho lasciato un lavoro perfetto: ben retribuito, a due passi da casa, con orari comodi e sicurezze intorno.
Eppure qualcosa dentro di me diceva “non è qui che sei felice”. Così, ho fatto un salto nel buio.
Ho lasciato la scrivania e sono passata a fare l’aiuto cuoca. Un lavoro faticoso, certo, ma pieno di vitalità. Ero circondata da persone vere, genuine, e soprattutto facevo qualcosa che mi dava gioia.
La verità è che l’ambiente, le persone e la piacevolezza in quello che fai non hanno prezzo. E lo rifarei altre mille volte.
Essere indipendente non vuol dire fare tutto da sola.
Vuol dire sapere quando fidarsi del proprio istinto, anche quando sembra andare contro la logica o le aspettative degli altri. Vuol dire anche assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Ma soprattutto, vuol dire non tradirsi mai.
E anche se a volte è stata una complicazione, non rinuncerei mai alla mia indipendenza. È la mia forza.
È il mio modo di essere nel mondo.
Nella mia vita, il lavoro è sempre stato una scelta consapevole, non un obbligo.
Anche quando era faticoso, anche quando significava rinunciare a comodità o sicurezze. Ho sempre voluto fare qualcosa che mi piacesse, che mi facesse sentire viva.
Ma con il tempo ho capito che il lavoro, per una donna, è molto più di un’attività. È uno strumento potente di autonomia, dignità e protezione.
Ho avuto un’esperienza importante come operatrice di ascolto in un centro antiviolenza, e posso dirlo con il cuore in mano:
l’indipendenza economica può fare la differenza tra restare vittime o trovare la forza di uscire da situazioni violente.
Ho ascoltato storie di donne di ogni età, provenienza, livello sociale e culturale. Tante differenze, ma un filo rosso le univa tutte: la violenza.
Per molte di loro, il lavoro era un sogno lontano, oppure un incastro impossibile tra figli, casa, mancanza di aiuti, giudizi familiari.
E spesso, l’impossibilità di mantenersi da sole era proprio ciò che le teneva bloccate.
Perché è facile dire “vattene”, ma come fai a farlo se non hai un reddito, una casa, una rete che ti sostiene?
La questione del lavoro femminile non è semplice.
Noi donne, ancora oggi, portiamo sulle spalle una doppia (e a volte tripla) fatica: essere presenti sul lavoro, a casa, nei ruoli di cura.
E spesso ci si aspetta che tutto questo accada in silenzio, senza chiedere troppo.
Ma non è giusto.
Basterebbe un po’ di aiuto in più dalla società: orari flessibili, servizi per l’infanzia, rispetto per il tempo e per le scelte delle donne.
Il lavoro non dovrebbe essere un lusso, ma un diritto.
Un diritto che significa poter camminare con le proprie gambe, decidere per sé, ricostruirsi anche dopo una caduta.
Io ho visto donne rinascere grazie a un lavoro.
Magari semplice, magari con pochi soldi all’inizio.
Ma loro, finalmente, potevano scegliere. E questo cambia tutto.
Osservo i giovani di oggi e dentro di me si mescolano tante emozioni.
Tenerezza, preoccupazione, curiosità, a volte incomprensione.
Li vedo spesso chiusi nel loro mondo, un mondo che passa attraverso uno schermo.
Li vedo spenti, come se qualcosa si fosse staccato dentro, come se facessero fatica a trovare una scintilla, una direzione.
Non voglio giudicare, ma mi preoccupa il loro futuro.
Quando ero giovane io – e non è nostalgia, è realtà si aveva fame di vita. Si prendeva quel che c’era, si provava, si sbagliava, ci si rialzava.
Oggi tanti giovani sembrano immobili, come in pausa.
Alcuni rifiutano il lavoro, altri ne hanno paura.
Molti sono delusi ancora prima di cominciare.
Eppure, proprio loro mi fanno pensare.
Forse siamo stati noi adulti a metterli dentro un sistema che corre troppo e dice poco.
Forse gli abbiamo dato troppe cose, senza lasciar loro spazio per guadagnarsele.
O forse non abbiamo dato abbastanza: ascolto, fiducia, esempi sinceri.
Io un po’ li capisco.
Il mondo che hanno davanti è fragile, rumoroso, confuso.
Non sanno cosa li aspetta, e intanto si perdono, spesso in silenzio.
Ho avuto la fortuna di lavorare in un centro antiviolenza.
Lì ho ascoltato donne giovanissime e donne mature. Tutte con storie diverse, ma con lo stesso nodo alla gola: la violenza.
E ho visto quanto l’assenza di un lavoro, di un reddito, di un'autonomia possa tenerle imprigionate.
Per questo penso che il lavoro non sia solo una fonte di soldi, ma una forma di rispetto verso se stesse, una porta verso la libertà.
Lo direi anche alle mie nipoti:
“Siate libere, anche economicamente. Non aspettate che qualcuno vi salvi. Imparate a salvarvi da sole, anche solo un po’.”
E ai giovani in generale, vorrei dire con affetto:
“Non abbiate paura della fatica. La fatica serve.
Non abbiate paura di sbagliare. Gli errori insegnano.
Cercate un lavoro che vi piaccia, anche se non è perfetto.
E se vi sembra di non trovare il vostro posto… cominciate a camminare. Il posto si trova lungo la strada.”
Devo ammetterlo: per me non è facile parlare di Wicca. È una parte intima, profonda, mia. Eppure, ogni tanto sento il bisogno di raccontarla… magari proprio qui, sul mio blog, dove le parole possono trovare spazio, tempo e senso.
Non è che io abbia qualcosa da nascondere, anzi. Ma quando ne parlo, le persone mi spiazzano sempre con domande strane, a volte curiose, a volte diffidenti, e altre semplicemente confuse.
E alla fine, l’unica cosa che sembra chiara a tutti è che sono una strega. 🙃
E allora sì, quando capisco che non vale la pena spiegare davvero, mi adeguo. Sto al gioco.
Mi diverto un po’ a farglielo credere, con uno sguardo misterioso o una risposta mezza seria e mezza no.
Dopotutto, chi non vorrebbe essere una strega ogni tanto?
Ma oggi vorrei provare a dire, con semplicità, di cosa sto parlando davvero quando dico che seguo la Wicca.
Non è una setta. Non è una moda. Non è magia da film.
È un modo di vivere, di sentire, di stare al mondo con rispetto, ascolto, amore per la Natura e per tutto ciò che vive.
È riconoscere che tutto è connesso, che ogni stagione, ogni luna, ogni battito ha un senso.
E sì, magari sono anche un po’ strega.
Ma nel senso più bello del termine: una donna che sceglie consapevolmente il proprio cammino.
La Wicca è spesso definita come una religione neopagana, ma per molti, me compresa, è molto di più: è un cammino spirituale, una filosofia, uno stile di vita in armonia con la natura e i suoi cicli.
Non ci sono dogmi, né verità assolute. La Wicca non impone, ma invita. Invita ad ascoltare, a osservare, a sentire.
È un sentiero libero, dove la connessione con la Terra, con la Luna, con gli elementi (Terra, Aria, Fuoco, Acqua) diventa una pratica quotidiana e sacra.


La Natura è sacra: tutto è collegato. Ogni pianta, animale, sasso, vento o goccia d’acqua ha uno spirito e un’energia.
Tutto ciò che fai, torna indietro: la famosa Legge del Tre, secondo cui ogni azione, positiva o negativa, ti tornerà indietro triplicata.
Rispetto per il libero arbitrio: nella Wicca non si manipola la volontà altrui. L’intento è fondamentale.
Il divino è dentro e fuori di noi: non c'è un solo dio, ma un’energia divina che si manifesta in molte forme. Spesso si onorano la Dea (femminile sacro) e il Dio Cornuto (maschile sacro), in equilibrio tra loro.
Gli elementi sono le forze fondamentali della Vita, presenti in natura e dentro di noi. Nella Wicca, si invocano spesso nei rituali, ma anche solo riconoscerli e onorarli è già un gesto potente.
Direzione: Est
Colore: Giallo
Stagione: Primavera
Parole chiave: pensiero, ispirazione, comunicazione, respiro
L’Aria è il primo soffio che accende la scintilla. È l’idea che nasce, il vento che libera.
Direzione: Sud
Colore: Rosso o arancione
Stagione: Estate
Parole chiave: passione, trasformazione, energia, volontà
Dentro di noi: è la forza che ci spinge ad agire, il desiderio, la rabbia, il coraggio
Il Fuoco è ciò che trasforma, che brucia e rigenera. È la fiamma che ci anima.
Direzione: Ovest
Colore: Blu o argento
Stagione: Autunno
Parole chiave: emozione, intuizione, sogno, guarigione
Dentro di noi: sono le lacrime, l’empatia, la memoria, l’amore profondo
L’Acqua scorre, accarezza e guarisce. È il nostro sentire più profondo.
Direzione: Nord
Colore: Verde o marrone
Stagione: Inverno
Parole chiave: stabilità, crescita, nutrimento, radici
Dentro di noi: è il corpo, la pazienza, la concretezza, la sicurezza
La Terra sostiene e protegge. È la Madre che accoglie e genera.
Con questo tatuaggio ho inciso su di me la mia scelta, la mia appartenenza, la mia connessione con il divino femminile, con la Luna e con i cicli della vita.
È come dire al mondo (e a me stessa):
“Io cammino con la Dea. Onoro ogni parte di me: la mia giovinezza, la mia pienezza, la mia saggezza. Io sono tutte queste cose. Io sono una con la Luna.”
E forse, in quel simbolo che mi accompagna sulla pelle, c’è anche la promessa di rimanere fedele a me stessa, di ascoltarmi, di rispettare i miei tempi e di seguire il mio sentiero con amore e con magia.


Ci sono cambiamenti che scegli.
E altri che arrivano come un’onda improvvisa, ti scuotono e ti obbligano a riprendere fiato con un'altra voce.
Quando sono rimasta sola, la casa dei miei a Lucca è diventata il mio rifugio. Un ritorno. Un riavvolgimento del tempo. Era lì, ad aspettarmi, come un libro lasciato a metà.
Lì ho cominciato a vivere in una dimensione nuova, fatta di silenzi diversi, volti sconosciuti, ritmi più miei. Tutto intorno a me è cambiato, ma a sorpresa… sono cambiata anch’io.
Avevo lasciato Lucca quasi 40 anni fa.
Una città elegante, viva, antica e testarda, come certe donne che non si piegano mai davvero.
Mi ero trasferita in un piccolo borgo, alle spalle di Viareggio. Una realtà più raccolta, dove tutti si conoscono e, in un certo senso, ti conoscono anche quando tu non vuoi.
Venendo da Lucca non è stato facile.
Non mi sono mai sentita parte di quel mondo. Ho cercato di integrarmi, ma qualcosa di me restava sempre fuori. Come se avessi lasciato una parte della mia anima appoggiata ai muri di una città fatta di pietra e memoria.
Per anni ho desiderato tornare. E quando si dice che bisogna stare attenti a ciò che si desidera… è vero.
Si è avverato. Ma non come avrei voluto.
Avrei voluto tornare insieme a lui.
In due. Per mano. Per scelta.
E invece ci sono tornata per necessità, con il cuore spezzato, e una nuova identità da ricostruire.
Eppure, Lucca mi ha stupita.
L’ho trovata diversa: più viva, più aperta, più accogliente. E forse sono io ad essere diversa.
All’improvviso mi sento un’altra persona.
Una che guarda avanti. Una che si concede di sbagliare, di ricominciare. Una che si sente a casa non tanto nei luoghi, ma nelle sensazioni. Una che ha trovato, nel cambiamento, una nuova forma di libertà.
La casa dove vivo oggi ha più spazio di quanto mi serva, eppure… in qualche modo, ogni angolo ha trovato il suo senso.
Ogni stanza racconta una parte di me: quella che crea, quella che ricorda, quella che riposa, quella che accoglie.
Non ho riempito solo spazi, ho costruito un equilibrio. Una specie di armonia domestica, fatta di luce, silenzi, piccoli riti quotidiani.
E anche se il palazzo in cui abito è modesto, il quartiere è signorile, elegante senza ostentazione, con quel fascino sobrio che Lucca sa offrire a chi la guarda con occhi gentili.
All’inizio avevo mille idee per il giardino.
Sognavo aiuole fiorite, angoli profumati, un piccolo regno verde dove affondare le mani nella terra.
Ma come spesso accade nei condomini, c’è sempre il Bastian contrario, quello che ha paura del cambiamento anche se si tratta solo di un vaso di lavanda.
Persone piccole, che passano il tempo a mettere zizzania…
Ma va bene così.
Ho imparato a non sprecare energie in battaglie inutili. I miei fiori li coltivo dentro, nei vasi, nei pensieri, nei rapporti veri.
Perché la verità è che oggi, finalmente, mi sento nel posto giusto.
E questa sensazione non ha prezzo.
Cammino a piedi e raggiungo tutto: uffici, supermercato, farmacia, palestra, parrucchiera…
E, ancora più importante: posso raggiungere le persone che amo.
Mi sento circondata, voluta bene. E questo fa tutta la differenza.
Non mi pesa vivere da sola.
Perché da sola non lo sono mai veramente.
C’è una rete silenziosa che mi sostiene: fatta di amici, parenti, vicini (quelli buoni!), persone che mi fanno sentire viva, vista, considerata.
E io, in questo spazio nuovo, sono diventata nuova anch’io.
Più centrata, più forte, più leggera.



Nella mia nuova vita, fatta di ritmi lenti, tempo per me e pensieri che finalmente trovano spazio, è arrivato anche lui: Amedeo.
Non è stata una decisione presa a cuor leggero. A lungo ho pensato che avere un gatto mi avrebbe limitato: negli spostamenti, nella libertà, nella possibilità di partire all’improvviso. Ma poi, come spesso succede con le scelte di cuore, non ho resistito.
Amedeo è un British Shorthair una razza inglese e, come ogni inglese che si rispetti, lui è elegante, riservato, un tantino snob. Ma quando decide di concedersi, diventa dolcissimo, un batuffolo di coccole che sa come scaldarti l’anima.
Per fortuna, la mia dirimpettaia Lia che chiamo affettuosamente "mamma 2" si prende cura di lui con un amore così profondo che a volte mi viene da pensare: “E se un giorno lui scegliesse lei?”.
Ma la verità è che non mi dispiacerebbe. Non sono gelosa. Non lo sono mai stata. Quando si ama davvero, non si possiede. E se Amedeo fosse felice, io lo sarei con lui.
La nostra convivenza è perfetta. Lui rispetta i miei spazi e io i suoi. Nessuno invade, nessuno pretende. Tornare a casa e trovarlo lì, che mi gira intorno alle gambe con la coda alzata come una bandiera della gioia, è impagabile.
E poi… è bello. Lo so, lo dico da mamma, ma quando guardo quel musetto paffuto e quegli occhioni tondi e intensi così rari nei gatti, mi viene voglia di stringerlo come un bambino. Anche se lui, va detto, detesta essere palpeggiato.
È la mia piccola presenza silenziosa, il mio compagno discreto. Non chiede nulla, eppure dà tantissimo.
Amedeo è casa.
C’è solo una cosa che mi mette davvero in ansia: quando Amedeo, con l’eleganza e l’incoscienza di un funambolo, si affaccia ai terrazzi e percorre tutta la ringhiera in equilibrio perfetto.
Io lo guardo col cuore in gola, pronta a chiamarlo, a correre, a intervenire… ma so che sarebbe inutile. È il suo istinto, la sua natura.
Come si fa a impedirlo? Sarebbe come vietare a un figlio di uscire per paura delle auto, delle cadute, della vita.
I pericoli esistono, certo.


Ma l’amore non può trasformarsi in prigione, né per un gatto, né per un essere umano.
Sarebbe un gesto egoista, un modo per placare la nostra ansia a scapito della loro libertà.
E allora lo guardo. Tesa, sì. In silenzio. Lo lascio fare, confidando nel suo equilibrio e nella sua saggezza felina.
È anche questo che ci insegna la convivenza con un animale: la fiducia.E l’accettare che l’amore vero, quello profondo, si manifesta anche e forse soprattutto nel lasciare andare.
A volte guardo Amedeo, il mio gatto, mentre si muove con eleganza sul bordo del terrazzo e mi viene un pensiero:
ma chi gliel’ha insegnato a stare così in equilibrio?
E soprattutto: perché io mi sento sempre così traballante, anche coi piedi per terra?
Noi esseri umani ci crediamo tanto speciali.
Pensiamo, parliamo, costruiamo, programmiamo… e poi ci perdiamo in un bicchiere d’acqua.
Gli animali invece vivono.
Mangiano quando hanno fame, dormono quando sono stanchi, amano quando vogliono… senza farsi mille domande.
Certo, noi abbiamo l’arte, la filosofia, il sushi vegano e le videochiamate.
Ma spesso ci dimentichiamo com’è stare semplicemente nel corpo, nel presente, in pace.
Un cane sa farlo.
Un gatto ancora meglio.
Noi abbiamo inventato il linguaggio per comunicare.
Loro ti guardano. Ti capiscono. Ti stanno accanto senza dire niente… eppure dicono tutto.
Amedeo, per esempio, quando mi metto giù a scrivere, viene e si accoccola vicino.
Non mi giudica.
Non mi corregge.
Non mi dice: “questo paragrafo è un po’ debole.”
Sta lì. E mi ricorda che il mio valore non dipende da quello che faccio, ma da come sto.
Da come amo. Da come respiro.
Forse la vera differenza tra noi e gli animali è che noi ci complichiamo.
Ci portiamo dietro passato, futuro, rimpianti, paure…
Loro no.
Vivono. Sentono. Si fidano (quando decidono che vale la pena).
E allora ogni tanto cerco di fare come loro.
Chiudo gli occhi.
Sento il sole sulla pelle.
E mi dico: “oggi non devo capire tutto. Oggi posso solo… esserci.”





Le fotografie non fermano il tempo… ma custodiscono ciò che conta davvero: l’amore che ci tiene insieme, anche quando siamo lontani, anche quando ancora non ci conosciamo.
Ci sono amori che non si spiegano. Nascono prima ancora che il tempo li renda visibili.
Io li chiamo i miei fili invisibili, quei legami che partono dal cuore e si allungano, si tendono, si moltiplicano, senza mai spezzarsi.
Amo i miei figli, da sempre. Dal primo battito che ho sentito dentro di me, da quel primo pianto che mi ha cambiato la vita. Amo i miei nipoti, ogni sorriso, ogni parola storta, ogni disegno spiegazzato che mi regalano come fosse un tesoro.
E poi ci sono loro. I gemellini che ancora non sono nati. Non li ho ancora visti, non li ho ancora tenuti in braccio, eppure li amo già.
Li immagino spesso: uno tranquillo e riflessivo, l’altra vivace e curiosa o forse sarà il contrario.
Mi chiedo se avranno gli occhi della loro mamma o il sorriso del papà, ma in fondo poco importa.
So solo che, da qualche parte, due anime piccoline stanno preparando il loro arrivo, e io sono qui, con il cuore spalancato.
È buffo come si possa amare qualcuno che non si conosce ancora. Eppure succede. È successo con i miei figli, poi con i miei nipoti, e ora con loro.
È un amore che non ha bisogno di vedere, toccare o capire.
È un amore che precede tutto. Che cresce da solo. Che esiste e basta.
Non ho molti ricordi di grandi feste familiari, di quelle con la tavola lunga, le risate che si intrecciano, i bambini che corrono tra le gambe dei nonni.
A parte qualche episodio sporadico, non sono mai state tradizioni della mia famiglia.
E non so perché. O forse lo so, ma non voglio scavare troppo.
È una mancanza silenziosa, che ogni tanto si affaccia nei miei pensieri.
Anche Pietro ne sentiva il peso, anche se non lo diceva mai apertamente.
Ci sarebbe piaciuto avere quei momenti: i pranzi rumorosi, le fotografie con tutti insieme, le ricorrenze da segnare sul calendario.
Ma è andata così.
Non si può avere sempre tutto.
A volte la vita non ti dà quello che ti aspetti, ma ti regala altro.
E allora impari ad amare quel che c’è: una telefonata improvvisa, un messaggio pieno d'affetto, un abbraccio atteso mesi.
Impari che una famiglia si può tenere insieme anche nei gesti piccoli, nei pensieri silenziosi, nei ricordi futuri.
E forse, un giorno, saranno proprio quei due gemellini a creare nuove tradizioni.
Magari loro inviteranno tutti, cucineranno troppo, rideranno forte e scatteranno foto buffe. E io, in qualche modo, ci sarò: in una storia raccontata, in un modo di ridere, in uno sguardo complice.
Perché l’amore vero non si perde, si trasmette
Daniele è il mio primogenito, il primo amore materno che mi ha cambiata per sempre. Nato sotto il segno della Vergine, lo incarna in pieno: preciso, affidabile, educato, gentile, premuroso… e anche un pochino ostinato, diciamolo! Ma è un testardo buono, di quelli che quando si mettono in testa una cosa non li smuove nessuno, soprattutto se quella cosa ha un valore profondo.
Di aggettivi per lui ne avrei a centinaia: è generoso, ironico, affabile, simpatico, estroverso, divertente. Una presenza che scalda. Colleziona cose antiche e vintage con una passione quasi romantica, e ha fatto della storia non solo una conoscenza, ma una passione. Contribuisce attivamente al Museo della Linea Gotica di Brancoli, dove mette cuore, mani e memoria, riportando alla luce frammenti del nostro passato.
Quando è nato, avevo solo 24 anni. Troppo pochi per rendermi pienamente conto di quale responsabilità stavo abbracciando. Ero ancora dentro quella fase un po’ immatura della vita, con la voglia di ballare, partire per le vacanze, stare con gli amici. Poi però è successo qualcosa: quel senso di protezione che nasce verso un figlio ti stravolge e ti ricentra. Ti insegna, piano piano, che l’amore vero passa avanti a tutto.
Ed è così che sono cresciuta io, insieme a lui.
Oggi abbiamo un rapporto fatto di affiatamento, di cura reciproca, di confidenza vera.
Da piccolo era un bambino curioso e incredibilmente socievole. Gli bastavano pochi minuti per fare amicizia con chiunque. Ricordo ancora quel giorno in cui avevamo dato un passaggio a una coppia di turisti tedeschi. Daniele era seduto dietro con loro, e a un certo punto lo abbiamo sentito conversare in tedesco, con una disinvoltura disarmante. Ci siamo voltati stupiti:
«Ma come fai a parlare in tedesco?»
E lui, con la naturalezza di un bambino che sa adattarsi al mondo, ci rispose:
«Mamma, io so qualche parola… e le ho usate.»
Ecco, Daniele è sempre stato così: aperto, curioso, intraprendente. Uno che non si tira mai indietro.
Oggi lo vedo come un uomo maturo, saldo, che prende le sue decisioni con consapevolezza e responsabilità. In questo momento sta lavorando a una casa vacanze di famiglia e io lo aiuto in tutto quello che posso. Il suo vero mestiere sarebbe il grafico un campo difficile, pieno di concorrenza e incertezze ma lui non si arrende. Non lo farà mai. E questo è uno dei tanti motivi per cui vado orgogliosa di lui.
Perché Daniele ha una dote speciale: riesce in quasi tutto quello che si mette in testa. Ha determinazione, visione, e un cuore grande.
Io sono sicura che la vita gli riserverà delle bellissime sorprese… e io sarò lì, al suo fianco, a sorridere con lui.

Fabio è nato nel 1991, sotto il segno dei Pesci, e già questo potrebbe bastare a spiegare molte cose: emotivo, silenzioso, profondo e imprevedibile. Ma per me, prima di tutto, è stato il figlio desiderato con tutta l’anima. Avevo 38 anni, un’età che all’epoca sembrava un po’ al limite per diventare madre, anche se oggi è quasi la norma.
Quando è nato, ho smesso di lavorare. Non ce l’ho fatta a conciliare la vita di mamma con tutto il resto, e lui questo piccolo essere così bisognoso e attaccato a me mi ha completamente assorbita. Dormiva poco, e solo nel lettone. Ma il vero nodo era l’attaccamento: aveva sviluppato un legame morboso con me, e io, inconsciamente, lo alimentavo. L’ho allattato fino ai 18 mesi. Era diventato una mia estensione, una mia appendice.
Avevo sempre paura che qualcuno me lo portasse via. Ero gelosa perfino delle altre persone della famiglia. Mi sono ritrovata ad avere un senso di possesso, di esclusività che non era sano, ma che allora non riuscivo a vedere. Vivevo per lui, ogni suo bisogno era un ordine. A 40 anni, ero una mamma-nonna: più apprensiva che autoritaria, più protettiva che autorevole.
Da piccolo era un terremoto. Correva, cadeva, si arrampicava ovunque, un po’ scapestrato ma con quel suo sguardo innocente che lo salvava sempre da ogni rimprovero. Un giorno, mentre stiravo, si è attaccato alla bottiglia della trielina che usavo per smacchiare. Una frazione di secondo. Poi la corsa in ospedale, la lavanda gastrica, l’angoscia, la paura... un incubo. E lui? Tranquillissimo. Il medico, forse per sdrammatizzare, gli chiese: “Ma cosa hai bevuto?” E lui, serafico: “La grappa.”
Già allora aveva un’ironia tutta sua.
Poi, verso i dieci anni, ha cominciato a guardare fuori dal nostro nido. A cercare il mondo. E alla fine, è volato via. La sua grande passione era la batteria, e io e mio marito l’abbiamo seguito ovunque ci fosse da sostenerlo. Era ed è davvero bravo, un talento naturale. Ma la vita non aveva scritto per lui il futuro di un musicista.
A sedici anni ha incontrato Jessica, l’amore della sua vita, e da allora non si sono più lasciati. A 22 anni è diventato padre. Un ragazzino, in fondo. È passato dalla PlayStation al cambio dei pannolini in un battito di ciglia.
E lì, da qualche parte, l’ho perso. O forse, semplicemente, è diventato grande.
Non è mai stato un grande confidente, non con noi genitori almeno, ma in fondo è perfettamente in linea con il suo segno: misterioso, introverso, profondamente legato ai suoi affetti, ma silenzioso nel mostrarli.
Quello che ammiro di lui e lo dico con tutto l’orgoglio possibile è la capacità con cui si è trasformato in un padre meraviglioso: presente, affettuoso, attento. Ha costruito una famiglia solida, piena di amore, sicurezza e serenità.
E se un tempo temevo che non si sarebbe mai staccato da me... oggi so che ha trovato il suo posto nel mondo. E lo ha fatto con il cuore.


Un piccolo esploratore di mondi, tra arte, movimento e libri divorati come patatine
Giona è un bambino fuori dal comune, con quella vena artistica che scorre nel nostro DNA di famiglia.
Il suo corpo cresce, certo, ma dentro è ancora tutto bambino, con l’entusiasmo e la leggerezza di chi guarda il mondo come fosse sempre la prima volta.
Non sta mai fermo — corre, salta, inventa — tranne quando ha un libro tra le mani. In quel momento, il tempo si ferma: legge con la stessa foga con cui altri sgranocchiano patatine.
Divora storie, accumula mondi, e questa sua passione lo porterà sicuramente lontano. Perché chi legge vive molte vite, e ogni pagina è un passo verso nuove conoscenze.
Ha lineamenti delicati, quasi eterei, e fino a poco tempo fa portava i capelli lunghi, che gli davano un'aria da fanciulla incantata, una piccola creatura di fiaba.
Giona è così: un po’ realtà, un po’ fantasia.
Non sa ancora cosa farà da grande, ma io ne sono certa: ci saranno di mezzo matite e fantasia. Perché la creatività lo guida già adesso, come una bussola gentile.
Paloma è una bambina dolcissima, nella fase incantata della preadolescenza, quando tutto si osserva con occhi nuovi ma già consapevoli.
Mi colpisce il suo modo di trattare le cose, come se ogni gesto fosse una carezza. Ha una grazia innata e una grande attenzione all’estetica, al bello che la circonda.
Anche se non ci vediamo spesso, ogni incontro è un piccolo dono: mi accoglie sempre con un abbraccio vero, caldo, avvolgente. Di quelli che ti scaldano il cuore e ti restano dentro.
È una nipotina perfetta, una bambina d’altri tempi, ma con lo sguardo curioso rivolto al presente.
Si muove con passi di danza, leggeri e armoniosi, come se ogni suo movimento seguisse una musica interiore.
I suoi lineamenti, come quelli di Giona, sono delicati come i suoi pensieri, e quando parla sceglie con cura le parole, esprimendosi in un italiano preciso, quasi musicale.
Di lei non so dire molto di più, ma so che vorrei conoscerla meglio e lo farò. Perché Paloma ha qualcosa di raro, di silenziosamente speciale, che lascia il segno anche con poche parole.

Di loro non so ancora niente. Non so che visi avranno, che caratteri porteranno con sé, né a chi somiglieranno.
So solo che li aspetto con tanta emozione e curiosità.
Due nuovi piccoli da amare, da conoscere un po’ alla volta.
E non vedo l’ora di vederli, tenerli in braccio e iniziare insieme questo nuovo capitolo di famiglia.
Ore 21:20. Il sole, dopo aver cotto a puntino tutto e tutti, ha finalmente deciso di tramontare. E meno male!
Oggi il termometro ha toccato i 38 gradi, e l’unica cosa che mi ha salvata dal liquefarmi è stato un improvviso raptus da scrittrice… roba da sudare anche i pensieri.
Domani, con un po’ di buon senso (e parecchia stanchezza), ho deciso che forse mi prendo una pausa.
Mi aspetta una giornata al Piccolo Paradiso, la casa vacanze di Daniele. Niente di mistico, ma abbastanza per staccarmi da questa sedia e dallo schermo che ormai conosce ogni mia espressione.
Mi muoverò, farò finta di essere attiva, e magari mi convincerò che è quasi come una vacanza.
Intanto il blog aspetta… e probabilmente tira un sospiro di sollievo anche lui.

Volevo aspettare almeno un altro giorno, darmi una pausa, respirare… Ma niente da fare: sono di nuovo travolta da questo raptus creativo che mi afferra senza chiedere permesso.
Mi chiedo se sia tornata la stessa mano che, anni fa, mi guidava mentre tracciavo figure a puntini, senza mai staccare la penna dal foglio, per ore e ore. Una mano invisibile, ostinata, che sembrava sapere esattamente cosa fare, come se io fossi solo lo strumento.
Una specie di fenomeno paranormale? Può darsi. Ma io, da strega, non mi stupisco più di tanto. Anzi, quando arriva, le faccio spazio.
Non disegna più, ora scrive. E io, come allora, la seguo.
Senza oppormi, senza staccarmi. Perché certe magie vanno assecondate.

C’era un tempo in cui non uscivo di casa senza essermi truccata.
Anche solo per cinque minuti. Anche solo per buttare la spazzatura.
Mi sistemavo il viso, le sopracciglia, un po’ di cipria e via.
E se incontro qualcuno?
Era una domanda che mi accompagnava spesso.
Non per vanità, ma per insicurezza.
Come se la mia faccia al naturale non fosse all’altezza del mondo esterno. Poi è cambiato tutto. O forse sono cambiata io.
Ho lasciato andare tante abitudini, tanti obblighi autoimposti.
Non mi sento più in dovere di apparire in un certo modo.
Esco spettinata, con la faccia pulita e un’aria da “prendimi così come sono”.
Ma c’è una cosa a cui non ho mai rinunciato: il rossetto.
Il rossetto, per me, non è un trucco. È un simbolo.
È la mia bandiera, il mio tocco di identità, il mio modo silenzioso di dire:
"sono qui, sono donna, e sono fiera di esserlo."
Sono ancora una femminista, sì. Ma una femminista femminile.
Una che crede che la forza non sia nel negare la dolcezza, ma nel saperla portare con fierezza.
Il rossetto sulle labbra è la mia armatura leggera.
Non per piacere agli altri, ma per ricordare a me stessa chi sono.
E se qualcuno mi vede col rossetto e la faccia stanca, poco importa. Vedrà una donna vera, che ha scelto ogni dettaglio.
Anche quello rosso acceso, fucsia o nude sulle labbra.
Perché il rossetto, per me, non è apparenza.
È presenza.


Una volta mi sembrava importante definirmi, appartenere a qualcosa. Poi ho capito che le etichette, spesso, ci stringono.
Ci chiudono in una forma che non ci somiglia davvero.
“Femminista”, ad esempio, è una parola che negli anni è stata travisata, usata, consumata.
A volte diventa un insulto, altre una moda. Ma per me, il femminismo è un dato di nascita: sono donna, e quindi porto con me il diritto, anzi, la necessità di difendere la mia voce, la mia dignità, il mio spazio. E' naturale che sia così.
Non mi serve l’etichetta per sapere chi sono. Sono femminile, a modo mio. Con il rossetto sulle labbra, la pelle senza trucco, le scarpe comode o i tacchi a spillo solo se mi va.
Non imito nessuno, non combatto contro nessuno. Rivendico solo la mia libertà di essere, ogni giorno, me stessa.
E se questo è femminismo, allora sì: lo sono ancora.
E forse lo sono sempre stata.
Oggi però voglio andare oltre: dare voce anche a chi quella voce l’ha persa.”
Il femminismo per me non è una lotta contro gli uomini, ma un grido contro la disuguaglianza. È la voce di tutte quelle donne a cui è stato tolto il diritto di scegliere, di essere, di vivere.
Quando prestavo il mio tempo al centro antiviolenza di Viareggio, ho toccato con mano storie che ti si piantano addosso e non ti lasciano più. Donne che hanno amato troppo. Donne che sono state costrette a chiedere scusa per essere vive. Donne che si sono sentite colpevoli solo per aver voluto essere felici.
E troppe di loro, quelle che non ce l’hanno fatta, sono diventate statistiche. Numeri freddi. Femminicidi.
Una parola dura. Ma necessaria. Perché se non nomini il male, non puoi combatterlo.
Essere femminista, oggi, per me è anche ricordare queste donne. Dare loro un posto nei nostri pensieri, nei nostri discorsi, nelle nostre pagine. È non accettare più il silenzio, l’indifferenza, le frasi come “se l’è cercata” o “era geloso perché l’amava”.
Io continuerò a mettere il rossetto, perché mi piace. Ma continuerò anche a raccontare, a scrivere, a dare voce. Perché ogni donna deve potersi guardare allo specchio e vedersi libera. Intera. Viva.
Lo ammetto: non sono brava a perdonare.
Non dimentico facilmente, soprattutto quando il colpo arriva da chi amavo, stimavo o semplicemente da chi pensavo mi volesse bene. Non è una guerra, la mia. Non faccio scenate, non cerco vendetta. Semplicemente, spengo la luce.
Le persone che mi feriscono smettono di esistere nel mio mondo emotivo. Se le incontro, le saluto, magari scambio due parole… ma è come parlare a un’ombra.
Il fatto è che quando qualcuno mi ferisce davvero, tocca le mie fragilità più profonde, senza alcun rispetto.
E lì mi trovo davanti a un bivio:
o scivolo nella rabbia e divento una persona che non mi rappresenta, oppure scelgo la via più silenziosa… e me ne vado. Scelgo di proteggermi. E scelgo il silenzio, che a volte fa più rumore di mille parole.
Forse questo mio modo di essere affonda le radici nelle mie origini sarde.
I sardi, quando si tratta di offese e rispetto, sono di pietra.
Lo era anche il mio babbo: un’offesa, per lui, non si superava così, con una stretta di mano e una pacca sulla spalla.
Quando ci siamo trasferiti in Toscana, questa cosa lo disorientava.
Vedeva le persone litigare violentemente, offendersi in modo pesante… e il giorno dopo ritrovarsi al bar, come se nulla fosse accaduto. Lui si stupiva. Non riusciva a capire quell’atteggiamento così lontano dal suo sentire. E si domandava: “Perché?”
Io non so quale sia la risposta giusta. Ma so che anch’io ho le stesse perplessità.
Qualcuno potrebbe pensare che sia fredda. La verità, però, è un’altra.
Dentro di me, anche se non lo do a vedere, spero sempre che l’altro capisca.
Che si renda conto del dolore che ha causato. Che apra gli occhi, che impari. Non per tornare da me. Non per rimediare.
Ma perché il male che si fa agli altri non dovrebbe passare inosservato.
È presunzione? Forse. O forse è solo il bisogno profondo di sapere che il mio dolore non è stato inutile. Che serva a qualcosa. Che qualcosa, nel cuore dell’altro, cambi.
Non ho la risposta giusta. So solo che preferisco il silenzio a una bugia, la distanza a una finta pace e la coerenza a un perdono forzato.
Siamo fatti così, ognuno con le sue fragilità.
Questa è la mia. E ho deciso di accoglierla, senza vergogna.
A volte non servono parole, basta allontanarsi con grazia... perdonare è un gesto nobile, ma non obbligatorio.

Quando sono nata, mio padre era già in marina, e la nostra vita si dipingeva di mare, di navi e di orizzonti lontani. Le nostre case erano prima la Maddalena e poi La Spezia, ma in quegli anni non eravamo mai davvero fermi. I ricordi di quel periodo sono sfumati nel tempo, ma una cosa mi è sempre rimasta impressa: mia madre raccontava che, a volte, ci spostavamo sulle navi dove mio padre era imbarcato. Non so perché, ma ogni volta che ci penso mi viene in mente quel film degli anni '50, Operazione Sottoveste, in cui le ospiti eccezionali stendevano la loro biancheria a mo' di bandiera e Immagino il cavo di ancoraggio di una corvetta decorato con le nostre magliette e mutandine... Forse era quella sensazione di essere sospesi tra un mondo di avventure e la realtà di una famiglia che cercava di stare insieme nonostante le difficoltà.
Ma, sebbene quelle navi fossero affascinanti, mio padre non era per noi bambini una figura di facile accesso. Era una presenza lontana, ma solida, imponente. Quando tornava a casa con la sua divisa nera d'inverno e bianca d'estate, io e i miei fratelli ci nascondevamo, perché la sua figura militare ci incuteva timore, un rispetto che a volte si trasformava in paura. La sua vita in mare, la disciplina, il rigore che lo accompagnavano, sembravano rendere il nostro mondo e il nostro rapporto più complicato.


Eppure, proprio quella distanza lo portò a prendere una decisione che segnò profondamente la nostra esistenza: rinunciare al sogno che amava di più, la sua carriera in marina, per tornare a casa e lavorare in impiego civile, alle Poste e Telecomunicazioni di Lucca. Quella decisione, oggi, la vedo come un atto di amore puro. Un amore che non si vedeva nei sorrisi o nelle carezze, ma nelle scelte difficili che ha fatto, per garantire un futuro migliore a noi.
Mio padre ha rinunciato ai suoi sogni per amore di noi, per offrirci una stabilità che non aveva mai avuto da bambino. La sua educazione, che ci sembrava a volte rigida e severa, oggi mi appare come il suo modo di proteggerci, di farci crescere forti e indipendenti. Lo vedevamo come un uomo severo, ma dietro quel volto di pietra c’era il cuore di chi sacrificava tutto per la propria famiglia.
Ora, con il cuore più maturo, capisco il peso di quel sacrificio. E se potessi tornare indietro, mi piacerebbe dirgli “grazie”, per ogni passo che ha fatto per noi, per ogni sogno che ha messo da parte. Ma, anche se lui non c’è più, so che in qualche modo ha sempre saputo quanto lo amavamo. E questa consapevolezza, oggi, mi basta.
Mia madre è stata un faro nella mia vita, una luce che non ha mai smesso di brillare. Quando penso a lei, il mio cuore si colma di gratitudine, ma anche di nostalgia. La ricordo nella sua età matura, quando la sua saggezza, l’acume e quella sottile ironia che non l’ha mai abbandonata sono diventati per me e per tutti un riferimento imprescindibile. Mia madre era un faro di tranquillità, ma anche di fermezza, una figura capace di trasformare ogni difficoltà in un’occasione per crescere, senza mai perdere il sorriso.
Da giovane, lavorava come sarta. Io e i miei fratelli, ma soprattutto io, portavamo con orgoglio i vestiti cuciti con le sue mani. Non erano vestiti alla moda, non avevano marchi prestigiosi, ma avevano qualcosa che nessun brand poteva mai avere: l’amore e l’attenzione di una madre che, con il suo talento e la sua dedizione, riusciva a creare qualcosa di unico per ogni uno di noi. La moda, a quei tempi, non era qualcosa da inseguire, ma qualcosa che nasceva dal nostro gusto personale. E mia madre sapeva valorizzare ogni nostra scelta, ogni nostro desiderio.
Era una donna semplice, ma mai banale. Aveva una cura particolare per se stessa, ma era la sua capacità di prendersi cura di noi, di tre figli, che la rendeva veramente speciale. Non era facile tenerci a bada, ma lei ci riusciva sempre, con un sorriso che spesso celava una fermezza che, da piccoli, sembrava più severità che amore. Eppure, anche nei suoi momenti di rabbia, con il suo carattere deciso, era sempre capace di trasformare ogni gesto in qualcosa che, con il passare degli anni, ho imparato ad apprezzare come affetto puro. Quella ciabatta lanciata in fretta, o quel pizzicotto che faceva male, ma che sapevi essere la sua forma di affetto, erano parte di quel modo unico e speciale che aveva di amarci.


La sua morte mi ha colpita profondamente. Ma con il tempo, guardandomi allo specchio, vedo sempre più spesso la sua immagine riflessa nei miei gesti, nei miei pensieri, e anche nel mio corpo. La casa che condividevo con lei, ora che vivo qui da sola, è diventata il suo rifugio e il mio, un luogo dove la sua presenza non è mai davvero andata via. A volte, cammino per le stanze, faccio gli stessi gesti che lei faceva, parlo con lei da sola, cosa che non ho mai fatto e mi sembra di sentirla ancora accanto a me.
Mia madre è vissuta fino a 90 anni. Fisicamente, la sua età cominciava a farsi sentire, ma la sua mente, il suo spirito, erano quelli di una ventenne. Chi l’ha conosciuta lo sa. Il suo sguardo era sempre proiettato lontano, eppure aveva la capacità di stare nel presente, senza mai giudicare, sempre aperta a ogni nuovo pensiero, sempre protettiva. Era capace di ascoltare, di dare il consiglio giusto, di vedere il lato positivo anche nelle difficoltà più gravi. La sua mente acuta e il suo cuore grande non conoscevano confini.
Anche ora, se mi fermo un attimo, riesco a percepire la sua protezione. Penso che sia rimasta qui, in questa casa, per continuare ad aiutarmi, per vegliare su di me nelle difficoltà quotidiane, piccole e grandi, che devo affrontare da sola. La sua presenza è ancora palpabile, nei silenzi, nei momenti di riflessione, nel modo in cui affronto le sfide della vita.
Sono felice di avere questa consapevolezza. La sua forza, il suo amore, il suo esempio sono dentro di me. Mi sento grata di poter portare avanti, con orgoglio, quella parte di lei che mi è stata trasmessa in ogni gesto, in ogni parola. In fondo, quando guardo me stessa, vedo anche lei. E so che, dovunque sia, continua a essere il mio faro, la mia guida.

Mi è venuta voglia di aggiungere un episodio che, pur essendo lontano nel tempo, dice molto sul clima culturale in cui vivevamo negli anni 80.
Ecco allora un ricordo del 1981, un anno importante per il Paese e, guarda caso, anche per me…
Certe date restano scolpite nella memoria. Il 5 agosto 1981, ad esempio, è il giorno in cui in Italia è stato finalmente abolito il delitto d’onore. Una svolta epocale. E guarda caso, proprio in quell’anno, anche la mia vita ha preso una piega altrettanto rivoluzionaria, almeno per me.
Mi sono separata dal padre di Daniele. Lui aveva appena sei mesi e io un coraggio che ancora oggi, ripensandoci, mi stupisce. Sono tornata a casa dei miei con una valigia di roba mia, un bimbo tra le braccia e zero certezze. Era un’epoca in cui una donna “per bene” non si separava. Figuriamoci con un figlio piccolo. Non vi dico i giudizi, i sussurri, gli sguardi. Eppure, non ho mai avuto dubbi: fu la scelta più giusta della mia vita.
Avevo un lavoro, sì, ma non mi permetteva l’indipendenza economica che desideravo. Così decisi di cercarne un altro, meglio retribuito. Sparsi un po’ la voce tra le amiche, ed ecco che una conoscente mi disse: “Ho la persona giusta per te”. Tempo un paio di giorni, squilla il telefono. Voce maschile, tono impostato: “Ci vediamo al bar accanto al suo ufficio, alle 18. Mi riconoscerà: cappello nero e giornale in mano.”
Lo ammetto, passai il pomeriggio tra il ridere e il preoccuparmi. Sembrava l’inizio di una spy story, ma il bar era terreno sicuro, frequentato da visi amici. Alle 18 spaccate, individuai il personaggio. Ci sedemmo, presi un caffè e ascoltai.
Cominciò a raccontarmi, con grande enfasi, delle sue conoscenze influenti, della sua abilità nel "sistemare situazioni complicate", e del suo altruismo nel “aiutare donne nella mia condizione”. A quel punto pensai: quale condizione? Io cercavo solo un lavoro migliore, non una rete di salvataggio.
Poi la perla: “Questa sera potrei anche presentarle un bancario… persona in gamba, ma ovviamente lei dovrà essere gentile… carina...”
Non aggiunse altro. Ma anche nella mia ingenuità di allora, avevo capito perfettamente a cosa stava alludendo.
Lo guardai dritto negli occhi, senza perdere la calma:
“Scusi, penso ci sia stato un equivoco. Io faccio l’impiegata, so scrivere, so usare la macchina da scrivere e rispondo al telefono. È questo il lavoro che cerco.”
Fu come gettare un secchio d’acqua gelata. Perse la pazienza, tentò qualche battuta allusiva e poi sparò la frase che mi è rimasta impressa più di tutte:
“Ma che lavoro pensa di trovare, separata e con un figlio?”
Mi alzai e me ne andai. Fine della sceneggiatura.
Perché racconto questo? Perché è bene ricordare che non molto tempo fa — sì, solo pochi decenni fa — bastava essere una donna sola con un bambino per essere automaticamente classificata come “problematica”. Altro che empowerment. Altro che meritocrazia.
Eppure, da allora tante cose sono cambiate, possiamo votare, lavorare, scegliere, parlare. Possiamo perfino lasciare un marito senza essere additate (o almeno, non troppo).
Ma non siamo arrivate in fondo. Per ogni diritto conquistato, c'è ancora un pregiudizio da smontare. Per ogni passo avanti, una voce da ascoltare, una storia da raccontare.
Questa è la mia. Una piccola storia. Ma tutte le grandi rivoluzioni cominciano da gesti semplici, da decisioni quotidiane, da bar e cappelli neri.

La Sardegna ha un’anima antica, profonda, misteriosa.
Un’isola che ha custodito nel silenzio delle sue pietre il segreto di una civiltà in cui la donna era al centro.
Non una principessa da salvare, ma una regina, una madre, una guida.
Nel cuore della civiltà nuragica, la Dea Madre era venerata come simbolo di vita, fertilità, protezione.
Le statuette ritrovate, con il ventre generoso e i seni prominenti, parlano ancora oggi con voce ferma: la vita nasce da qui.
E da allora, forse, non è mai cambiato davvero.
Le donne sarde hanno sempre avuto un ruolo forte, anche quando non si vedeva.
Madri, mogli, sorelle, contadine, sarte, tessitrici, erboriste, levatrici.
Dentro ogni casa e fuori erano loro a decidere, a tramandare, a resistere.
Non urlavano, non imponevano. Ma c’erano. Sempre.
Ricordo mia madre, per esempio.
Semplice, elegante, saggia e ironica.
Parlava poco, ma quando lo faceva usava il sardo. Le sue parole sembravano uscire da un tempo lontano.
Raccontava piccole poesie, filastrocche, storie di donne forti.
Le ho imparate senza volerlo, e ancora oggi, a volte, mi escono dalla bocca senza preavviso, come un richiamo del sangue.
Un giorno mi disse una frase che non ho mai dimenticato:
“Is feminas fortes no ant bisogniu de gridai.”
(Le donne forti non hanno bisogno di gridare.)
Anche nei riti e nelle feste popolari si sente questa eredità.
A Posada, ad esempio, durante la Festa di Sant’Anna, si celebra sì una santa, ma anche una madre, una donna che protegge, consola e rinnova la vita.
E non è un caso: dietro a quei canti, a quei gesti, si nasconde il profumo di culti antichi, di cerimonie pagane, di matriarcalità sopravvissuta sotto altri nomi.
Oggi molte cose sono cambiate, ma non tutto.
Le donne sarde sono ancora quelle che portano avanti la casa, i figli, spesso anche il lavoro fuori.
E lo fanno con fierezza, con quella durezza gentile che è solo loro.
Una durezza che non è chiusura, ma radice.
Non è isolamento, ma orgoglio.
Io mi sento figlia di questa terra e di queste donne.
Anche se la vita mi ha portata lontano, il mio cuore parla ancora con l'accento della mia isola.
E quando mi guardo allo specchio nei giorni più difficili, so che dentro di me vive quella forza silenziosa che ho visto in mia madre, in mia nonna, e in tutte le donne sarde che non ho conosciuto, ma che mi hanno tramandato , come un canto antico, il coraggio di restare in piedi.
Rituale sacro di una single al tramonto
Ore 20.00.
Il caldo pesa come un pensiero di troppo.
Le finestre sono aperte, le tende si muovono appena, come a danzare.
E io, che sono single, ho deciso che questa è l’ora giusta per un rito tutto mio:
un aperitivo alcolico per svuotare la testa, alleggerire il corpo… e forse anche il cuore.
Un Martini, due olive.
Una per me.
Una per quella parte di me che ogni tanto dimentico di coccolare.
Sorso dopo sorso, i pensieri si sciolgono come il ghiaccio nel bicchiere.
I muscoli si rilassano, le spalle si abbassano, e nella mente comincia a suonare quella canzone… quella che mi fa venire voglia di ballare e anche altro...
E allora via le scarpe.
Piedi nudi sul pavimento fresco, un passo, una giravolta, uno sguardo al soffitto come se fosse cielo.
Ballo da sola, ma non sono mai stata così in compagnia.
Perché una donna che balla con sé stessa, che si sceglie, che si brinda…
è già piena d’amore.
C’è il tempo per studiare, il tempo per lavorare fuori, e poi arriva il tempo in cui si resta a casa: quello che chiamano pensione, come se fosse un premio. E in effetti lo è. Una specie di vacanza lunga… ma senza il costume da bagno e con qualche acciacco in più.
Sono in pensione da quattro anni. Quattro. Mi sembra ieri, eppure… mi sento ancora capace di fare mille cose. Forse solo novecentonovantotto, ma insomma, il margine c’è ancora. Eppure ogni giorno mi accorgo che la forza e soprattutto l’entusiasmo iniziano a vacillare, come una sedia a dondolo che ha perso un chiodo. Funziona ancora, ma fa un po’ di rumore.
Ci vorrebbe un’inversione di marcia, una trovata geniale. Un’idea da film, tipo Il curioso caso di Benjamin Button. Ecco, quella sì che sarebbe una soluzione brillante: nascere vecchi e migliorare con il tempo. Invece no. Noi si fa il percorso classico: nasciamo freschi come rose e finiamo appassiti come carciofi dimenticati in fondo al frigo.
Ora che potrei finalmente godermi il tempo, ora che potrei andare a lezione di ballo, imparare il giapponese o buttarmi su una carriera da cantante lirica... ecco, proprio ora mi manca la cosa fondamentale: la giovinezza.
E non serve a niente cercare di ingannare lo specchio. Lui sa. Il corpo segue un suo destino: le ginocchia scricchiolano, la schiena fa male, e la voglia di mettersi i tacchi passa in automatico alla voce "fantascienza".
Ma nonostante tutto... che meraviglia questo tempo maturo. È il momento delle ciliegie rubate dalla vita, dei pensieri lucidi, dei sorrisi senza fretta, delle risate con chi ti conosce da sempre. E poi c'è il grande lusso: poter scegliere. Anche solo se stirare subito o mai più.
La verità? Non vorrei tornare indietro. Forse un giorno sì, per curiosità. Ma poi tornerei esattamente qui. Con qualche ruga in più e mille storie da raccontare.

Viviamo in una società che celebra la giovinezza come fosse l’unica stagione degna di nota. Tutto ruota attorno a corpi tonici, sorrisi bianchi, esperienze da “brivido”. Si invecchia, ma in silenzio, come se fosse una colpa.
E allora si prova a nascondere il tempo con filtri, trattamenti, ritocchi, posture giovanili. Si evita di parlare di malattia, di perdita, di fine. Gli anziani diventano specchi scomodi, perché ci ricordano che non siamo eterni, che anche noi rallenteremo, perderemo qualcosa, cambieremo forma.
Ma non è la vecchiaia a far paura. È l’idea di diventare inutili, soli, dimenticati.
Così capita che si guardino gli anziani come si guarda un oggetto smarrito: con un misto di tenerezza e fastidio. Si sorride, ma poi si cambia corsia. Ci si commuove, ma poi si torna alla corsa.
Eppure in quegli sguardi c’è il nostro futuro. Perché tutti, se ci va bene, diventeremo vecchi.
«La vita è come un tessuto ricamato: il diritto lo ammiri da giovane, il rovescio lo comprendi da vecchio.»
– libera ispirazione da Schopenhauer
La vita è come un tessuto ricamato. Nei primi anni, quando il filo è ancora nuovo e la vista limpida, osserviamo il diritto del ricamo: colori vivaci, disegni armoniosi, tutto ci appare come un insieme perfetto, quasi magico.
Ma è solo con l’arrivo della vecchiaia che ci è concesso di girare quella stoffa e vedere il rovescio. E sebbene possa apparire più confuso, pieno di nodi e intrecci apparentemente disordinati, è proprio lì che si rivela il senso di tutto: ogni filo ha una direzione, ogni passaggio ha lasciato un segno.
La vecchiaia, spesso vista come una resa o una sconfitta, è in realtà una fase di rivelazione.
È il momento in cui, liberi dai pregiudizi e dalle illusioni che ci accompagnano nella giovinezza, possiamo osservare la realtà con occhi nuovi. Non ci interessa più correre, competere, apparire. Non abbiamo più l’urgenza di dimostrare nulla. E questa libertà, che arriva solo col tempo, ha il sapore della verità.
I sogni dei giovani, così belli e impetuosi, si scontrano con la saggezza dei vecchi, che hanno imparato che non tutto si può ottenere, e che spesso la felicità è nascosta nelle piccole cose.
È come se, svanita la frenesia della volontà di vivere – quella che ci faceva muovere, sbagliare, rincorrere – tornassimo a uno stato simile all'infanzia: non più fatto di domande esistenziali, ma di pura contemplazione.
La vecchiaia può diventare così un ritorno all’essenza, un’epoca in cui rallentare ci permette di cogliere la bellezza nascosta.
Come quando da bambini osservavamo le nuvole, ascoltavamo i rumori della natura o restavamo incantati di fronte alla danza della luce sul pavimento. Non c’era bisogno di capire, bastava sentire.
E allora forse, questo tempo apparentemente vuoto è invece un’occasione: per ridere di noi stessi, per guardarci dentro senza paura.
È il tempo del raccoglimento, della cura, della lentezza che rivela.
È il rovescio della stoffa.
E finalmente, capiamo che anche lì, nel groviglio dei fili, c’è un disegno.
Sto vivendo la mia terza età... e ci sto da dio.
Non mi annoio, non mi sento finita, né parcheggiata.
Scrivo, dipingo, vedo amici, giro, ascolto storie. E anche quando non faccio nulla, riesco ad apprezzare il silenzio, la lentezza, la staticità. È un lusso poter fermarsi, respirare e semplicemente essere.
Certo, c’è qualcosa che mi preoccupa: il tempo.
Scorre troppo in fretta.
Ho sempre mille idee, progetti, sogni, e a volte ho paura che non mi basti una vita sola – o tre – per fare tutto ciò che vorrei.
Ma poi mi dico: ogni giorno che riesco a dedicare a qualcosa che amo, è già un piccolo capolavoro.
Tra le cose che più mi nutrono, c’è il mio impegno nel volontariato.
Faccio parte di un'associazione che si chiama “Daccapo – Sistema di Riuso Solidale”, un progetto bellissimo promosso dalla Caritas, che unisce sostenibilità ambientale, economia circolare e aiuto concreto alle persone.
Recuperiamo abiti, biancheria, oggettistica… li selezioniamo con cura: un po’ li distribuiamo gratuitamente a chi ne ha bisogno, un po’ li vendiamo nell’emporio solidale. E tutto il ricavato torna sempre alla comunità, a chi ha più bisogno.
È un “lavoro” fatto di mani, cuori e sorrisi.
E anche se non porta guadagni in tasca, arricchisce l’anima ogni volta.
Perché fare del bene, senza chiedere nulla in cambio, è uno dei pochi gesti che ci rende veramente umani.
E allora sì, la vecchiaia può essere anche questo:
non una stagione di rinuncia, ma un tempo di dono,
non un epilogo, ma un nuovo inizio.
Non sono in pensione, sono in produzione: bellezza, gesti buoni e idee nuove.
Mi perdo tra oggetti da riordinare e pensieri da ricucire.
Ma è tutto tempo ben speso.




Quando ho lasciato la scrivania da impiegata, sapevo solo una cosa con certezza: quello non era il mio posto felice.
Non sapevo ancora dove mi avrebbe portata la mia ricerca, ma avevo capito che dovevo muovermi, cambiare, mettere le mani in qualcosa di vero.
Quel qualcosa, sorprendentemente, fu la cucina.
E tutto cominciò da un mazzo di prezzemolo e da un uomo che incuteva un certo timore Salvatore, lo chef ufficiale dell’Ideal Party di Viareggio.
Salvatore era uno di quei personaggi che lasciano il segno. Con la giacca sempre bianca e l’aria di chi ha cucinato anche sotto le bombe, non era esattamente un tipo da abbracci e complimenti. Brusco, autoritario, a tratti persino antipatico... eppure, con me fu diverso.
Perché, si sa, le persone hanno sempre un lato giusto da cui prenderle.
E io, evidentemente, l’avevo trovato.
Con lui ho cominciato dal basso, ma proprio dal basso basso, tagliando prezzemolo e pelando montagne di patate. All’inizio mi sembrava un lavoro inutile, una specie di punizione per novellini.
Invece no. Quelle erano le fondamenta, i gesti semplici che insegnano il rispetto del tempo, dell’ingrediente e del mestiere.
Nel mondo del catering non esistono ruoli fissi: si cucina, si serve, si monta e si smonta, si scarica e si ricarica… e si riparte. Ma vista la mia passione, finivo quasi sempre in cucina.
È lì che ho imparato davvero: come organizzare i tempi, come intuire dosi e sapori anche quando non puoi pesare tutto al grammo.
Come salare l’acqua della pasta per cinquanta persone.
Come cuocere su fornelli da campo con un occhio al pentolone e l’altro alla scaletta del servizio.
E come tenere a bada quella paura che, diciamolo, non se ne va mai del tutto quando sai che stai cucinando per un matrimonio, e non puoi sbagliare.
Oppure quando stai friggendo e ti senti osservata da una platea affamata con l’aria da giudici di MasterChef.
È stato tutto faticoso, ma anche incredibilmente bello.
Una strada piena di sfide, sì, ma anche di scoperte, di risate dietro le quinte e di soddisfazioni che non hanno prezzo.
E pensare che, all’inizio, sapevo fare giusto due uova al tegamino.
Un po’ storte.
Un po’ tristi.
In cucina, come nella vita, non basta seguire la ricetta.
Ci vuole intuito, coraggio e – soprattutto – fantasia.
Perché la verità è che in cucina la fantasia non è un optional: è una necessità.
Serve quando manca un ingrediente, quando i tempi stringono, quando le cose non vanno come previsto.
E a volte... anche quando uno zuccotto decide di sciogliersi come un gelato al sole.
Ricordo ancora quella volta in cui dovevo portare in tavola uno zuccotto.
Come da tradizione: si presenta il dolce agli ospiti con eleganza, lo si fa ammirare e poi si riporta in cucina per affettarlo.
Peccato che quella sera il frigo fosse troppo caldo, o forse io troppo di fretta… fatto sta che il dolce ha iniziato a franare lentamente da un lato, come un ghiacciaio stanco.
Attimo di panico.
Un minuto di silenzio.
Poi l’illuminazione: un fiocco!
Avevo per caso un nastro a portata di mano (non chiedetemi perché… forse i segni dell’universo esistono davvero).
L’ho avvolto intorno al dolce, stretto bene e creato un bel fiocco laterale.
Zuccotto salvo, figura elegante, applausi assicurati.
Nessuno ha saputo la verità.
O forse sì… ma quella sera la fantasia ha avuto la meglio sulla pasticceria.
E io ho imparato che anche i disastri possono diventare capolavori, se li guardi con un po’ di creatività e un bel fiocco pronto all’uso.



Prima di raccontarvi della musica che mi accompagna ogni giorno, voglio aprire una piccola parentesi, un po’ delicata forse, ma per me importante.
Viviamo un tempo in cui la Russia viene spesso vista con sospetto, a volte persino con ostilità. Ma io, prima di lasciarmi travolgere da giudizi politici e slogan preconfezionati, ho deciso di pensare con la mia testa. E ci tengo a raccontarvi perché.
Ho lavorato per cinque stagioni con una famiglia russa a Forte dei Marmi. Una famiglia facoltosa, sì il livello sociale era alto, altissimo ma quello che mi ha colpita non è stato il lusso. È stata la loro umanità.
Sono stata accolta fin dal primo giorno come una di famiglia. Nessuna distanza, nessuna puzza sotto il naso, nessuna diffidenza. Solo fiducia.
La signora Ludmilla una donna semplice e gentile mi ha coinvolta nella sua vita come si fa con una sorella. Dipingevamo insieme, andavamo in giro per negozi, viaggiavamo… e io, naturalmente, mi prendevo cura di lei con la stessa dedizione che si ha verso una persona cara.
Lui, più austero, ex militare, un uomo di poche parole, ma con uno sguardo che sapeva ascoltare. Alla fine delle cene importanti, quando la villa era piena di ospiti, mi chiamava nella sala da pranzo. E con quel suo tono severo ma rispettoso, mi presentava come l’artefice della serata.
E sapete cosa succedeva?
Un applauso. Un applauso in piedi. Per me.
Ma quando mai in Italia?
Quando ripartivano, mi lasciavano le chiavi della loro villa, senza esitazione. Io mi trasferivo lì, con la mia famiglia, e avevo persino accesso al loro bagno privato al Twiga dove, tra l’altro, ero stata presentata come "amica".
È stata un’esperienza indimenticabile. Un lavoro sì, ma con un’anima dentro. Un’esperienza che mi ha insegnato a guardare oltre i titoli dei giornali, oltre le generalizzazioni, oltre i confini.
Non voglio fare politica, non è il mio mestiere. Ma la gratitudine e il rispetto sì, quelli sono affari miei.
E oggi li dedico al popolo russo, per la loro cultura, per la loro generosità, per il modo sincero in cui sanno accogliere.
Forse, prima di giudicare, dovremmo provarci anche noi.
A guardare le persone. Non solo i telegiornali.

Viviamo in un mondo dove le notizie ci raggiungono a raffica, ogni ora, ogni minuto.
Titoli che gridano, immagini che colpiscono, parole che dividono.
È difficile restare lucidi. È difficile pensare con la propria testa, soprattutto quando si parla di temi enormi come una guerra.
La guerra in Ucraina è uno di quei temi. Ognuno ha la sua versione, la sua verità, il suo nemico. Ma io non sono un’analista politica.
Sono solo una persona che, un giorno, ha incontrato dei russi veri.
Non in TV, non nei talk show.
Li ho incontrati a Forte dei Marmi, in una villa elegante dove ho lavorato per cinque stagioni, prima in cucina, poi come parte della famiglia. Con loro non mi sono mai sentita "serva", ma parte di un tutto. E non parlo solo di soldi o buona educazione parlo di umanità. Per questo, oggi, mi sento confusa davanti al disprezzo generalizzato verso tutto ciò che è “russo”.
Come se la colpa di un governo, di una guerra, ricadesse su ogni singolo cittadino, su ogni volto, su ogni lingua.
Mi chiedo:
🧠 Quante delle nostre opinioni sono davvero nostre?
📺 E quante ce le hanno messe in testa a forza, un telegiornale alla volta?
Io non ho risposte, solo una certezza: l’incontro diretto è l’unico antidoto al pregiudizio. Perché un popolo non è un governo.
Una guerra non cancella la gentilezza.
Un pregiudizio è un’opinione o un giudizio formulato in anticipo, senza una conoscenza reale, approfondita o diretta di una persona, un gruppo, una situazione o un fatto.
È come se la mente, per comodità o per abitudine, decidesse prima ancora di sapere davvero.
Pensare che una persona sia poco affidabile solo perché appartiene a una certa etnia.
Credere che un anziano non possa capire la tecnologia.
Pensare che tutte le donne non sappiano parcheggiare (😅 questo lo sentiamo spesso, eh?).
Il pregiudizio si nutre di stereotipi, cioè idee semplificate e generalizzate. E il problema è che, se non ci facciamo caso, può condizionare i nostri comportamenti e portarci a trattare male qualcuno senza motivo.
In sintesi:
🧠 Il pregiudizio è un giudizio dato prima di conoscere.
💭 Spesso nasce dalla paura del diverso o dall’ignoranza.
❤️ Si combatte con la curiosità, l’ascolto e l’esperienza diretta.
📺 Ripetizione e narrazione
I media, attraverso notizie, pubblicità, film e programmi, ripetono certi messaggi fino a renderli “normali” o “ovvi”.
🗞️ Scelta delle parole e del tono
Una manifestazione può essere definita “pacifica” o “pericolosa”, a seconda dell’intento del giornalista o del canale. Le parole plasmano
Assolutamente sì.
Come ogni conflitto, la guerra in Ucraina è raccontata in modi diversi a seconda di chi racconta.
I media occidentali tendono a difendere l’Ucraina e a condannare la Russia.
I media russi raccontano l’opposto: si difendono da ciò che chiamano una "minaccia NATO".
Alcuni analisti geopolitici provano a vedere anche le cause più profonde, storiche, culturali, economiche.
Io non ho risposte, solo una certezza: l’incontro diretto è l’unico antidoto al pregiudizio.
Perché un popolo non è un governo. Una guerra non cancella la gentilezza. E dietro ogni bandiera, c’è una storia che merita di essere ascoltata.
E forse è proprio questo che manca nel rumore del mondo: l’attenzione.
Quella vera, silenziosa, che si concede alle persone senza volerle incasellare o giudicare.
Quella che si prova solo quando si è disposti a mettere da parte le certezze per lasciare spazio all’incontro.
“L’attenzione è la forma più rara e più pura di generosità.”
Simone Weil
E io, quell’attenzione, l’ho ricevuta da chi molti oggi chiamano “nemico”. E la restituisco, come posso, con queste parole.

La musica ci consola, ci solleva, ci fa piangere quando ne abbiamo bisogno e ci fa ballare quando vogliamo dimenticare. È come un'amica che non fa domande, ma capisce tutto.
Quando ero molto giovane, diciotto anni o giù di lì, grazie a mio fratello Giorgio, che era ed è un appassionato di musica, ho intrapreso il mio primo vero viaggio nell’universo dei suoni. Con lui ho imparato ad apprezzare la musica non commerciale, quella profonda e visionaria dei Pink Floyd, dei Genesis e di altri artisti straordinari. Suonava in un gruppo che si chiamava "Circuito Integrato" e andavo spesso ad ascoltarlo durante le prove: per me era magia allo stato puro.
A volte in casa rimanevo sdraiata al buio con le cuffie nelle orecchie, completamente immersa nel brano "The dark side of the moon" proprio dei Pink Floyd. Le note diventavano paesaggi, le voci si trasformavano in visioni. Vedevo mondi surreali, provavo strane sensazioni di cadute e risalite, come onde interiori che mi attraversavano.
Non so cosa sia la droga, ma credo che certe esperienze musicali si avvicinino molto: ti portano altrove, senza bisogno di altro che un po’ di silenzio e un cuore pronto ad ascoltare.
C’è chi dice che la musica è un passatempo. Per me è una medicina invisibile, un abbraccio che arriva senza mani.
È quella cosa che non chiede nulla ma ti dà tutto.
Quando la tristezza pesa, allora basta premere “play”.
Un pianoforte lento, una voce roca, un ritornello che ti conosce meglio di te stessa. E improvvisamente… respiri.
La musica entra nel corpo senza bussare. Accende il cuore, rilassa le spalle, mette in ordine i pensieri. Ti riporta indietro nel tempo, ti fa compagnia nel presente, ti fa sognare il futuro. Ho sempre ascoltato musica. Da ragazzina la mettevo a tutto volume, oggi la scelgo con più attenzione. Ma ogni volta, è come se parlasse solo a me.
Una canzone giusta nel momento giusto può cambiarti l’umore, il passo, la giornata.
E quando condividi una canzone con qualcuno, è come dire:
“Ecco, questo sono io. Ascoltami.”
La musica può fare molto più di quanto immaginiamo. Non è solo piacere, è cura, compagnia, medicina dell’anima
🎵 Emozionalmente:
La musica ci consola, ci solleva, ci fa piangere quando ne abbiamo bisogno e ci fa ballare quando vogliamo dimenticare. È come un'amica che non fa domande, ma capisce tutto.
💓 Fisicamente:
Ascoltare musica rilassa il corpo, abbassa la pressione, migliora il battito cardiaco. Alcune melodie influenzano addirittura il respiro. E quando balliamo? Facciamo ginnastica… senza accorgercene!
🧠 Mentalmente:
Stimola la memoria (quante volte una canzone ti riporta indietro nel tempo?), migliora l’umore e aiuta nella concentrazione. La musica classica, ad esempio, può aiutare nello studio e nel sonno.
🤗 Socialmente:
Unisce le persone. Ci fa cantare in coro, ballare insieme, sentirci parte di qualcosa. Ha il potere di superare le barriere: linguistiche, culturali, generazionali.
💫 Spiritualmente:
Per molti è quasi una preghiera, un rituale. Ti mette in connessione con qualcosa di più grande, ti porta “altrove”, anche solo per tre minuti.

C'è chi legge l'oroscopo e c'è chi lo canta sotto la doccia. A ogni segno il suo umore, a ogni umore la sua colonna sonora.
Per gioco, per passione o per semplice curiosità, ho immaginato una playlist stellare, dove le stelle non si leggono, ma si ascoltano.
E se ti ritrovi nella tua canzone, beh... forse non è solo una coincidenza! 😉
🔥, 🐏, 🏃♂️.
Brucia come 🔥 e canta come se la vita fosse una 🥊 da vincere a ritmo di 🥁.
🧘♂️, 😍, 🌿.
Ama con lentezza 🐢, costruisce 🧠 a piccoli sorsi di 🎼, come un 🍷 buono.
💨, 🤹♂️, 💡.
Una 🎤 qua, un pensiero là. I ♊ sono un duetto continuo con sé stessi 🪞.
💞, 🌊, 😢.
Ogni 🎶 è una 🤗, ogni accordo un 🤍: il ♋ ascolta con il ❤️ prima che con le 👂.
🦁, ✨, 🎭.
Quando entra, si sente 📣. Quando canta, è il ⭐. Anche sotto la 🚿.
🔍, 🎯, 🧠.
Nella 🎵 cerca verità nascoste 🕵️♀️, vibrazioni perfette 🎼, bellezza ordinata nel caos 🔲.
⚖️, 🎀, 🌹.
Ogni parola pesa come una 🪶 d’oro 💛. Ama l’arte dell’equilibrio anche tra le 🎶.
🦂, 🕶️, 🔥.
L’amore è un 🎲 pericoloso, e lo ♏ ne conosce la 🎞️ a memoria.
🏹, 🧭, 🚀.
Ogni 🎵 è un 🚆 in corsa, ogni ritornello una 🌄 aperta sul 🌍.
🏔️, 💪, 😶.
Non cerca scorciatoie ⛔, ma salite da scalare con la 🎶 a scandire il 🦶.
🔮, 🆓, 👽.
Pensa avanti ⏩, sogna oltre 🌠. Le sue playlist sono fatte di ⭐ e ✊.
🎨, 😔, 💧.
Ogni 🎵 è un 🌙, ogni melodia una 🌊. I ♓ non ascoltano la 🎶… ci 🐠 dentro.
Ricevo dei messaggi bellissimi sul blog. Uno, in particolare, diceva così:
"Ti dedico questa canzone dopo aver letto il tuo blog, sei una persona unica. Il tempo che trascorre non intacca la tua genuinità, freschezza, profondità."
Quando leggo certe parole, provo un misto di gratitudine e imbarazzo. Non fraintendetemi, i complimenti mi piacciono, li accolgo con un sorriso... ma dentro di me si accende quella vocina che sussurra: “Ma davvero parlano di me?”.
Forse è un pizzico di timidezza, o forse è solo che non mi sono ancora abituata all’idea che quello che scrivo, spesso di getto, senza filtri possa davvero toccare qualcuno.
Nel blog mi sento libera. Scrivo come se nessuno stesse leggendo, e forse è proprio questo il segreto.
Qui non c’è un pubblico con occhi puntati addosso, non c’è il fruscio della sala che si placa prima che tu apra bocca, non c’è il microfono che ti amplifica l’ansia.
Qui è come lanciarsi con il paracadute da mille metri: dall’alto non vedi le case, non vedi le strade... e nemmeno le persone.
Solo cielo.
E nel cielo ci si sente leggeri, invisibili e... sinceri.
La verità è che ho sempre avuto difficoltà a parlare in pubblico.
Già il numero “sei persone” per me rappresenta una soglia psicologica. Superata quella, la voce comincia a tremare, le mani sudano e nella testa si fa il vuoto cosmico.
Eppure una volta ho persino frequentato un corso di recitazione, convinta che mi avrebbe aiutata a vincere questa paura. Non ha funzionato. O meglio: mi ha fatto capire che il palcoscenico non fa per me.
Ricordo un episodio tragicomico.
Ero stata scelta da Ersilia Raffaelli, presidente del centro antiviolenza per cui facevo volontariato, per salire sul palco e ringraziare il Comune di Massarosa, alla fine di una commedia teatrale.
Poche parole, nulla di complicato:
"Il centro antiviolenza L’una per l’altra ringrazia il Comune di Massarosa per il suo sostegno."
Facile, no?
No.
Prima di entrare in teatro mi sono fermata al bar, pensando che un goccio di qualcosa di forte mi avrebbe dato coraggio. Peccato che il “goccio” si sia trasformato in un bicchiere troppo generoso... risultato? Euforia alle stelle, sicurezza sotto le scarpe.
Quando toccò a me, riuscii solo a dire: “Il centro antiviolenza ringrazia.”
Stop. Fine. Sipario.
Non una gran figura, ma nemmeno un disastro. In fondo nessuno si aspettava un discorso da premio Nobel.
Da quel giorno ho smesso di cercare di forzarmi. Non tutti siamo fatti per stare su un palco, e va bene così. Io mi esprimo meglio da dietro uno schermo, con le parole che scorrono libere, senza il filtro della timidezza.
Scrivere è il mio modo di parlare al mondo… con il paracadute ben allacciato, ma con il cuore aperto.

🪂 PS. Quando parlo di “scrivere con il paracadute”, non è solo una metafora.
Ho fatto bel tre lanci veri, uno più emozionante dell’altro. E sapete una cosa? Lassù, non c’è paura. Solo vento in faccia e un senso di libertà assoluta.
Peccato che su un palco non si possa indossare un paracadute… forse me la caverei meglio.

La moglie dell’uomo estremo (che non voleva aspettare a casa)
Avevo circa ventitré anni. Un’età in cui ti senti eterno, protetto dall’entusiasmo, e dove la forza fisica ti regala quella sensazione pericolosa chiamata onnipotenza.
Ero appena sposata con il mio primo marito, amante degli sport estremi. Mi trascinava in avventure di ogni tipo. Io, da parte mia, ci provavo a volte per sfida, a volte solo per non stare a casa ad aspettarlo.
Tra tutte, la montagna resta una delle esperienze più audaci… ma il paracadutismo, quello sì, ha lasciato un segno.
Per lanciarsi con il paracadute, ovviamente, bisogna seguire un corso. Niente di trascendentale, ma comunque impegnativo. Quando iniziai, non pensavo davvero che sarei arrivata al lancio.
Mi dicevo: “Posso sempre tirarmi indietro all’ultimo.”
Ma questi corsi sono costruiti con astuzia. Non ti allenano solo fisicamente: c’è anche un lavoro psicologico sottile, coinvolgente, che ti lega al gruppo e ti mette in testa un solo obiettivo: il lancio.
Dopo l’esame finale, alla Caserma Gamerra di Pisa, non potevo più tornare indietro.
Ero l’unica donna del corso: 48 chili per un metro e sessanta, in mezzo a una squadra di ragazzi robusti. Mi prendevano in giro dicendo che, con il mio peso, sarei rimasta in aria più degli altri.
Spiritosi…
Peccato che questo non mi facesse sentire più sicura.
Il primo lancio fu una giornata perfetta: cielo limpido, niente vento una vera fortuna.

Il punto di ritrovo era l’aeroporto di Tassignano. Si saliva su un piccolo velivolo il Cessna 152 che sorvolava un’area delimitata: troppo stretta, però, per lasciare spazio a esitazioni.
Bisognava stare attenti: bastava sbagliare il tempo e si poteva finire sui fili della luce, dentro un campo di granoturco, o peggio… sul tetto di una casa
E naturalmente… la prima a lanciarsi ero io.
ed io come prima al lancio sentivo la responsabilità per i ragazzi che mi seguivano
Esco, mi posiziono all’esterno dell’aereo, stringo la maniglia sotto l’ala, come avevamo imparato. Il vento è fortissimo, ho la sensazione di essere strappata via come una foglia... ma resisto.
Aspetto il segnale del direttore di lancio: pollice alzato.
È il momento.
Apro le braccia.
Mi butto indietro.
Il volo libero dura pochissimo un lampo, un respiro trattenuto poi sento il paracadute aprirsi. La cosa più importante.


Nonostante si cada a una certa velocità, non lo percepisci. Ti senti sospesa, leggera. Il mondo tace.
Dovrei ripassare mentalmente le manovre di atterraggio, ma voglio godermi il silenzio e quella sensazione meravigliosa di volare.
Atterro.
Resto sdraiata sull’erba a guardare il cielo.
Penso solo:
"Ce l’ho fatta. Ho volato."
Da fare invidia a Leonardo.
Avrei dovuto alzarmi subito, come da regolamento, per segnalare che stavo bene… ma sinceramente?
Con tutto quello che avevo in testa, non potevo certo ricordarmi anche questo dettaglio.
Perché quel momento il momento del lancio è diventato per me una lezione di vita.
La decisione di buttarmi, lì aggrappata sotto l’ala dell’aereo, era cruciale. E da quella scelta istintiva, ma consapevole, ho imparato qualcosa che mi porto ancora dietro.
Io, che per carattere e forse anche per colpa della Bilancia, il mio segno zodiacale, sono stata nella vita un po’ indecisa di fronte alle grandi scelte.
Rimuginavo, riflettevo, pesavo, confrontavo e comunque il risultato non era scontato. Eppure, da quel giorno, ho scoperto che quando il tempo stringe, il mio cervello si trasforma in un computer. Valuto velocemente tutte le opzioni, analizzo i rischi e... decido.
Non sempre va tutto liscio, certo. Ma almeno non perdo tempo.
E questo, credetemi, è un potere che non si insegna nei corsi, ma che si conquista con l’aria in faccia e un salto nel vuoto.

Ho sempre immaginato la vita come un viaggio in treno: a tratti lenta, a tratti frenetica, con tante fermate, alcuni passeggeri che restano, altri che scendono.
Questo è il racconto del mio percorso… che non è ancora finito, ma che valeva la pena scrivere.
Forse sono un po’ lunga… lo so.
Ma ci tenevo a raccontare questo viaggio fino in fondo, come viene, senza tagli.
Se avete voglia di restare, anche solo per qualche fermata, salite a bordo. Il treno parte. E io vi aspetto al finestrino. 🚂🌸
Sono salita su un treno il giorno in cui sono nata.
Non ricordo bene la stazione, ma so che c’era odore di latte caldo, lenzuola ruvide e voci di donne.
Il treno era già in movimento, lento e regolare, come un respiro. Nessuno mi chiese il biglietto: avevo il passaggio garantito, come tutti.
Da allora ho viaggiato senza sosta. Ho visto i finestrini cambiare paesaggio, ho imparato a riconoscere le stazioni dal suono della frenata.
A ogni fermata, qualcuno saliva.
Alcuni rimanevano per poco: una bambina con le trecce che rideva sempre, un signore che parlava da solo, una donna con gli occhi tristi e una scatola piena di sogni.
Altri invece si sedevano accanto a me e restavano per chilometri e chilometri, come se avessimo un biglietto in comune.
Alcuni li ho amati. Altri li ho dimenticati.
Ma tutti, in un modo o nell’altro, hanno lasciato qualcosa nel mio vagone.
Forse la vita è proprio questo: un lungo viaggio in treno, con incontri che ci cambiano più delle destinazioni.
Il vagone dell’infanzia
Era un vagone più basso, o forse ero io che guardavo il mondo da sotto in su.
I sedili erano troppo grandi per le mie gambe corte, i finestrini sembravano tele altissime dove si rincorrevano campi di grano, tetti rossi e rondini in volo.
C’era sempre odore di buono: pane appena sfornato, minestra calda, sapone di marsiglia. E il rumore delle ruote sui binari mi sembrava una ninna nanna.
Il primo a sedersi fu mio padre. Silenzioso come certi passeggeri che leggono il giornale ma tengono l’orecchio teso.
Era una figura imponente, sempre in piedi accanto alla porta, come se dovesse scendere da un momento all’altro.
Poi arrivò mia madre, con le mani piene di tutto. Lei sistemava, aggiustava, sapeva sempre cosa mancava nel vagone, a volte anche prima che mancasse.
Un giorno salì anche mio fratello Stefano.
Fu in quel momento che capii una cosa importante: non sarei mai più rimasta sola. Da una parte mi rassicurava, lo ammetto. Ma dall’altra… beh, non ero più al centro della scena, e un po’ mi seccava.
Però gli volevo già bene. Era piccolo, tenero, e portava con sé un’energia nuova.
Poi, qualche tempo dopo, arrivò Giorgio.
A quel punto mi fu chiaro che quella porta del vagone si sarebbe aperta ancora, e ancora… forse all’infinito.
Ogni nuovo passeggero portava qualcosa, e io imparavo a fare spazio, un po’ per forza e un po’ per amore.
I passeggeri invisibili
C’erano quelli che non si sedevano mai, ma passavano veloci tra i vagoni lasciando scie: una maestra con l’alito di caffè e la voce ferma, una vecchia vicina che odorava di talco, un gatto grigio che dormiva acciambellato sul mio zaino.
Nessuno parlava mai davvero di dove stavamo andando. Ma ogni tanto qualcuno mi indicava un dettaglio:
– Guarda quel campo laggiù, sembra un tappeto…
– Hai visto com’è lunga questa galleria? Ma poi si esce… sempre.
Fu in quel vagone che imparai le cose fondamentali: come si aspetta, come si ascolta, come si piange in silenzio. Ma imparai anche a ridere. Di gusto. Di gola. Di pancia. E ogni volta che qualcuno scendeva, lo guardavo dal finestrino finché spariva.
Mi sembrava una cosa ingiusta, ma poi capii: il treno è mio, ma non posso trattenerli tutti.
Quando avrei voluto scendere
Non sempre il viaggio è stato facile. Ci sono stati momenti in cui il treno correva troppo veloce, e io non riuscivo a respirare. Altre volte, invece, era il vagone a farsi pesante.
Non per i miei bagagli, quelli li portavo da tempo, ma per quelli degli altri.
Persone che salivano col cuore a pezzi, e mi raccontavano le loro storie, e io assorbivo tutto.
Ma a volte il loro dolore si infilava nel mio, come un ago che passa due stoffe insieme.
E non riuscivo più a distinguere dove finivo io e dove cominciavano loro.
Mi è successo, sì, di avere voglia di scendere. E non una sola volta.
Ma c’è stato un giorno, no, un intero mese, in cui davvero avrei voluto tirare il freno d’emergenza.
In quell’arco breve e assurdo ho perso due delle persone più care della mia vita: mia madre e mio marito.
È stato come se un sipario nero fosse calato all’improvviso, cancellando tutti i colori. Il treno non si è fermato, ma io sì.
Mi sono seduta in un angolo del mio vagone e ho smesso di guardare fuori.
Il tempo non passava. Non c’erano paesaggi. Solo un buio uniforme e silenzioso.
Eppure, qualcosa, o qualcuno, è passato anche quella volta. Non so chi fosse. Forse il controllore di sempre. Forse una voce interiore, un gesto, un ricordo.
So solo che mi ha sussurrato una frase che porto dentro ancora oggi:
"Non ti sarà dato niente che non puoi sopportare."
E da quel momento, lentamente, ho iniziato a vedere. Perché se riesci anche solo per un secondo a intravedere i colori nel buio… non può succederti niente di definitivo.
È come se il treno stesso, capendo il mio dolore, avesse rallentato un po’, aspettandomi.
La fermata dei colori
Ricordo ancora quella stazione. Non aveva nome, o forse l’ho dimenticato. Ma appena il treno si fermò, qualcosa cambiò.
Sul marciapiede c’era una bambina che disegnava con i gessetti colorati. Disegnava case storte, alberi viola, persone che sorridevano. Il cielo era verde, il sole aveva gli occhiali da sole.
Mi venne da ridere, per la prima volta dopo tanto tempo. E capii che i colori non erano spariti. Erano semplicemente scesi a prendere un caffè alla fermata.
In quel momento capii anche un’altra cosa: non devo aspettare che la vita mi porti qualcosa. Devo essere io, ogni tanto, a dipingere il mio vagone con i colori che scelgo.
Anche se tremano le mani. Anche se fuori piove.
Il cambio di vagone
Non era previsto. Non c’era nessun annuncio, nessun capotreno che mi avvisasse.
Semplicemente, un giorno, mi sono alzata dal mio sedile. Ho guardato fuori dal finestrino, poi ho guardato dentro di me… e ho capito che non stavo più bene lì.
Il vagone dove avevo viaggiato fino ad allora era comodo, conosciuto, persino affettuoso in certi momenti. Ma qualcosa si era spento. I colori erano sbiaditi, le parole erano diventate abitudine. I volti che mi circondavano parlavano, ma non mi ascoltavano più.
E allora l’ho fatto.
Ho preso la mia borsa, non tutta la vita, solo l’essenziale e mi sono avviata verso la porta che collega i vagoni. Tremavano le mani, lo ammetto. Avevo paura che una volta aperta quella porta non ci fosse nulla. Solo vuoto tra un vagone e l’altro.
Ma invece c’era un piccolo passaggio, stretto e rumoroso, che vibrava sotto i piedi. E io, in bilico tra passato e futuro, l’ho attraversato.
Il nuovo vagone aveva un odore diverso. Odore di novità, di legno fresco, di pagine ancora da scrivere. Nessuno mi stava aspettando. Ma proprio per questo… mi sentii libera.
Mi sedetti accanto al finestrino e lasciai che l’aria mi spettinasse i pensieri. Mi sentii viva. Finalmente. Cambiare vagone non è tradire la propria storia, è salvarla.
A volte bisogna avere il coraggio di alzarsi e dire:
“Questo viaggio è mio. E oggi scelgo io dove voglio stare.”
Il nuovo vagone profumava di possibilità. Aria nuova, volti nuovi, orizzonti aperti. Ma la sorpresa più grande fu ritrovare chi pensavo fosse sceso per sempre. Seduta vicino al finestrino, un po’ più avanti del mio posto, c’era Lia.
La riconobbi subito, anche se era un bel po’ che non la vedevo. Lei era identica a come la ricordavo: forte e gentile, come una brezza che sa essere carezza e tempesta.
Lia non era solo una persona. Era una presenza, un campo energetico tutto suo.
La sua bellezza era mediterranea: armoniosa, riccia, piena. Occhi profondi come pozzi antichi, mani che danzavano anche da ferme.
Insegnava danza orientale, meditazione, silenzi. Ti insegnava, senza mai spiegare, come si torna a casa… dentro se stessi.
Non avevo idea che anche lei avesse cambiato vagone. Forse pensavo di averla persa a una stazione qualsiasi, inghiottita da quei saluti che sembrano definitivi. E invece eccola lì.
Non mi salutò con parole, ma con un abbraccio e un sorriso. Uno di quelli che ti passano attraverso.
E dentro quel sorriso c’era tutto:
– il “sono felice di rivederti”
– il “ce l’abbiamo fatta”
– il “non siamo mai state davvero lontane”
Stare con Lia è come bere da una fonte segreta nel mezzo del deserto. Una che sa riconoscere la tua sete prima ancora che tu ti accorga di avere la gola secca.
Quando sei con lei ti senti leggera, come dopo una lunga dormita, o dopo aver pianto tutto.
C'è in lei qualcosa di antico e di moderno insieme: una donna, una amica, una madre, una sorella.
Il suo abbraccio non è solo fisico: ti avvolge l’anima. In quei primi giorni nel nuovo vagone, fu lei la mia medicina. Mi insegnò che cambiare, lasciare, perdersi… sono tutte forme d'amore.
E che le persone giuste, se davvero lo sono, ritrovano il tuo treno, sempre.
l vagone silenzioso
Questo vagone non fa rumore. Le ruote girano come sempre, ma sembrano scivolare più dolcemente sui binari.I sedili sono più larghi, il tessuto consumato ma accogliente. Il sole entra inclinato, come fosse sempre pomeriggio. Il tempo qui dentro è diverso: non corre, non si ferma. Fluttua.
In questo vagone non si parla tanto. Ma si ascolta moltissimo.
È qui che davvero il paesaggio. Le colline lontane. Le case isolate. Gli alberi che cambiano colore con le stagioni. Tutto ciò che prima ignoravo perché troppo impegnata a vivere… ora lo vedo.
E mi commuove.
Diventare guida
Ora sono io che siedo vicino ai più giovani. Quelli che salgono di corsa, con le cuffiette nelle orecchie e lo zaino pieno di domande.
A volte mi guardano con aria sospettosa, altre con quella fame che solo chi cerca qualcosa di vero conosce.
Non sempre parlo. A volte basta uno sguardo, un gesto, una frase buttata lì:
– “Non aver paura di cambiare vagone.”
– “Non devi sapere sempre dove stai andando, basta sapere chi sei.”
– “Non tutto quello che perdi era destinato a restare.”
E loro ascoltano. Anche se fanno finta di no.
In questo vagone ho capito che essere guida non vuol dire indicare la strada.
Vuol dire camminare accanto, anche solo per un tratto, e offrire un pezzo di pane quando l’anima ha fame. E magari raccontare una storia.
Qui non si urla, non si corre. Ma ogni tanto, qualcuno si avvicina e mi dice: “Posso sedermi accanto a te?” E io rispondo sempre di sì.
Perché: quando sai stare bene da sola, sei pronta a stare bene con gli altri. E il silenzio non è più vuoto, è spazio.
Spazio per ascoltare. Per respirare. Per amare senza fretta.
La stazione del perdono
Non c’era scritto il nome sul cartello della stazione. Solo un simbolo: un nodo sciolto. Il treno rallentò, e io lo sentii. Non era una frenata brusca. Era più un respiro profondo, come quando si decide di affrontare qualcosa che si è evitato per anni.
Il paesaggio era familiare eppure diverso. Vecchie immagini si riflettevano sui vetri: volti, parole, stanze.Alcune sfocate, altre nitide come schiaffi.
Sapevo cosa stava per succedere: ero arrivata alla stazione dove si fa pace col passato.
Il peso nello zaino
Avevo portato con me per tanto tempo uno zaino invisibile.
Dentro c’erano frasi non dette, ferite mal curate, rimpianti piegati in quattro.
C’erano colpe che non erano mie, ma che avevo preso per gentilezza. C’erano persone che non mi avevano chiesto scusa, e io continuavo ad aspettarle.
In quella stazione, per la prima volta, ho aperto lo zaino. E invece di rimettere tutto dentro, ho scelto cosa lasciare.
Ho lasciato l’orgoglio di voler aver ragione.
Ho lasciato la rabbia di non essere stata capita.
Ho lasciato la me stessa bambina che aspettava amore da chi non era capace di darlo.
Una figura è salita sul treno in quel momento. Non aveva volto, ma sentivo che era una parte di me. Mi si è seduta accanto in silenzio. E dopo un po’ ha detto:
– “Non sei tenuta a perdonare tutto. Ma puoi smettere di farti del male.”
Io non risposi. Ma qualcosa si sciolse dentro. Come neve al sole. Come una corda che si allenta.
Quando il treno è ripartito, mi sono sentita leggera. Come se, per la prima volta, il vagone fosse in equilibrio con il mio cuore. Non ho dimenticato. Ma ho smesso di portare con me ciò che non serve al viaggio.
L’ultima fermata (ma non proprio)
Quando il treno ha iniziato a rallentare, l’ho capito subito.
Non era una frenata d’emergenza, né una di quelle soste rumorose con il fischio del capotreno.
Era un rallentare dolce, come quando ci si accorge che non c’è più bisogno di correre.
Il paesaggio fuori dal finestrino era cambiato: meno città, meno stazioni affollate, più alberi, più cielo. Nessun annuncio alla radio. Nessuna voce metallica a indicare la fermata. Solo una scritta, apparsa sul vetro appannato dal mio respiro:
“Fine corsa… o forse inizio?”
Mi sono alzata dal sedile. La valigia era leggera, quasi vuota. L’essenziale era tutto dentro di me.
Guardandomi intorno, ho visto altri passeggeri fare lo stesso: alcuni che conoscevo bene, altri che avevo solo incrociato, tutti con lo stesso sguardo: non triste, ma consapevole.
Siamo scesi insieme, in silenzio. Ma non c’era binario, non c’era marciapiede. Solo un sentiero sterrato che si perdeva tra gli alberi, e mentre camminavo, pensavo:
non ricordo tutte le stazioni,
non ho più i biglietti,
non so nemmeno dove andava davvero quel treno.
Ma so chi ero quando sono salita. E so chi sono ora che sono scesa.
E questa, forse, è l’unica vera destinazione.
Non è un addio
Non so se questo sia davvero un finale. Forse è solo un cambio di mezzo. Da treno a piedi. Da rotaie a sentieri. Oppure un passaggio a una dimensione dove il tempo non ha orari e i ricordi camminano accanto a te senza far rumore.
Ma una cosa è certa: non è finita.
Il cuore batte ancora. La mente sogna ancora. E anche se il treno ha smesso di correre,
la vita continua.
Cambia forma.
Diventa respiro.
Diventa luce.
Diventa altro.

Una volta ho sognato che sarei morta a 71 anni.
Lo so, suona drammatico… ma era più un incubo che un sogno.
Me lo disse una strana presenza incontrata in uno di quei sogni lucidi che facevo in un periodo particolare della mia vita, quando Fabio era ancora piccolo e il sonno notturno era diventato un lusso. Così, il pomeriggio, mentre lui dormiva, mi sdraiavo sul divano e cercavo di riposare anch’io.
Ma il mio riposo era tutto tranne che normale. Cominciai a sognare con una lucidità inquietante. Sapevo di sognare.
E nel sogno potevo muovermi, decidere, esplorare. Una specie di universo parallelo che mi accoglieva ogni volta che chiudevo gli occhi.
Diventò quasi una dipendenza. Aspettavo quel momento come si aspetta un appuntamento segreto.
Un giorno, accompagnai mio marito al lavoro. Lui doveva parlare con alcune persone, io rimasi in auto. “Perfetto” pensai. Un’occasione ideale per verificare se quei luoghi che visitavo in sogno esistessero davvero. Chiusi gli occhi. E ci entrai di nuovo.
Mi ritrovai dentro una torre, su una scala a chiocciola. Salivo, piano, ma con determinazione. In cima, una figura umana. Il volto? Non l’ho mai visto. Ma la voce… quella sì. Mi disse:
"Come hai fatto ad arrivare fino a qui? Nessuno può arrivare qui. E ora non posso farti tornare indietro…"
Mi gelai. Domandai: “Dove sono?” La risposta:
"Sei oltre la vita. Ma non è ancora il tuo momento. Morirai a 71 anni."
Mi diede anche la data precisa, ma e per fortuna l’ho dimenticata.
In quel momento ho cercato disperatamente di svegliarmi. Ma non ci riuscivo. Né schioccare le dita, né muovere le gambe, né gridare. Niente. Sentivo il cuore stringersi, come se fossi davvero intrappolata in un aldilà senza ritorno. "Sono morta", pensai.
E ho provato la paura più grande.
Quella del non esserci più. Di non rivedere i miei figli, la mia casa, la mia vita.
Poi, all’improvviso, qualcuno mi ha scosso: era mio marito. Avevo gli occhi chiusi e le lacrime che mi scendevano sul viso.
Li ho aperti. Ero viva.
Col tempo ho ripensato spesso a quel sogno. Non tanto con paura, ma con una certa curiosità. Era solo frutto della stanchezza? Di una mente creativa e un po’ provata?
Oppure era davvero un messaggio, un’anticipazione, una spinta a svegliarmi?
Quello che oggi mi sento di dire è che forse quella “morte” non era reale. Forse era solo un simbolo. Una fine… e un inizio.
La fine di una versione di me. La nascita di un’altra, che ha iniziato a scrivere, a raccontare, a osare di più.
Ora che mi avvicino a quell’età, non sento paura. Sento gratitudine. Perché sto vivendo questo tempo con più coscienza. Forse la vera rivelazione di quel sogno era questa:
che la vita ha un tempo, e quel tempo è prezioso.
E poi…
Anche se vivessi fino a cent’anni, so bene che, nella migliore delle ipotesi, gli anni ancora veramente pieni, quelli degni di essere vissuti con intensità, non potranno essere più di quindici. E sono ottimista.
È per questo che non voglio sprecare un solo minuto.
Perché ogni giorno che passa, ogni singolo istante, diventa più raro. Più delicato. Più mio. E se davvero esiste un aldilà… spero che mi accolga con una valigia piena di giorni vissuti fino in fondo.
Anche perché, io non credo nella fine. Credo nella trasformazione. Siamo energia, e l’energia non si perde. Cambia forma, si sposta, danza nell’universo.
E forse un giorno tornerà a farsi sogno. O fiore. O voce in cima a una scala a chiocciola.
“Non credo nella fine.
Credo nella trasformazione.
Siamo energia: e l’energia non si perde.
Si trasforma in sogno, in vento, in luce.”


A volte arrivo in ritardo.
A un appuntamento, a una consapevolezza, a una decisione che avrei potuto (forse dovuto) prendere prima.
Mi capita anche con le emozioni: le capisco dopo, le accetto dopo, le affronto quando ormai sembravano passate di moda.
Eppure, ogni volta mi ricordo che “in ritardo” è sempre meglio che “mai”. Perché “mai” è rinuncia. È chiudere la porta, è non provarci, è non crederci più.
“In ritardo” invece ha ancora il cuore che batte. Anche se un po’ affannato. Anche se si sente in colpa. Ma è vivo.
E dove c’è vita, c’è possibilità. C’è un gesto da fare, una parola da dire, un sogno da rincorrere anche se zoppica.
Ci sono fioriture che non rispettano il calendario. Ci sono anime che si svegliano tardi, ma poi danzano fino all’alba.
E allora sì, arrivo in ritardo. Ma arrivo.
Con tutta me stessa.
Ci sono ancora tante cose che devo fare.
E sì, mi sento spesso in ritardo.
Ma guardandomi indietro, mi accorgo che di strada ne ho fatta tanta, anche se a volte l’ho percorsa in direzioni insolite, fuori dal sentiero tracciato, fuori dall’approvazione degli altri.
Ho potuto farlo grazie al mio compagno di vita, un uomo che non mi ha mai ostacolata, mai trattenuta, mai giudicata.
Anzi, mi ha sempre spinta a realizzare i miei sogni grandi o piccoli che fossero appoggiando ogni mia iniziativa, anche le più particolari. E questo, credetemi, è stato uno dei doni più grandi che la vita mi abbia fatto.
C’è stato un periodo in cui ho frequentato l’Associazione Archeosofica: una libera scuola di pensiero fra studiosi e sperimentatori di cultura fisica e spirituale.
Un luogo che mi ha affascinata e fatto riflettere, dove ho imparato a non prendere con leggerezza certi temi così sottili e profondi.

I corsi che ho seguito sono stati molti:
erboristeria,
pittura iconografica,
astrologia,
radioestesia
…e molto altro.
Esperienze intense, non sempre semplici da spiegare, ma piene di senso.

Ad esempio, la radioestesia, che ai più può sembrare una curiosità folcloristica, in realtà affonda le sue radici in pratiche millenarie: l’uso del pendolo, la ricerca dell’acqua con la forcella, strumenti usati in tempi antichi quando non esistevano le nostre tecnologie, ma l’intuito e il legame con la natura erano vivi e presenti.
Oggi questi saperi non sono riconosciuti dalla comunità scientifica.
Eppure, in un’epoca in cui anche la scienza viene manipolata per interessi poco nobili, forse dovremmo davvero tornare un po’ indietro.
Non per rinnegare il progresso, ma per riscoprire le nostre capacità naturali, quell’intelligenza intuitiva che ci appartiene da sempre.
Sì, forse sono in ritardo su molte cose. Ma non mi sono mai fermata. E ogni deviazione, ogni curiosità, ogni ricerca ha avuto un senso.
Mi ha resa più me stessa.
Magari sono in ritardo… ma almeno ho avuto tempo per godermi il panorama!




Una volta pensavo che col tempo tutto si sarebbe sistemato:
i dubbi si sarebbero sciolti, le risposte avrebbero preso forma, e io sarei diventata finalmente… una persona “a posto”.
(Spoiler: non è successo.)
A cinquant’anni ero convinta di aver scritto tutto quello che avevo da scrivere. Invece, sorpresa: mi sono riscritta.
Sono cambiata, sono ripartita, ho buttato via qualche vecchio schema mentale (e pure due paia di scarpe), e mi sono detta: “Va bene così. Anche se non so esattamente dove sto andando.”
E sai una cosa? C’è qualcosa di meravigliosamente leggero nel perdersi. Perché smetti di dover dimostrare, di dover pianificare ogni mossa. Ti lasci sorprendere da una nuova passione, da una frase scritta per gioco che ti scava dentro, da un colore che ti chiama mentre guardi una tela bianca.
Rinascere non è sempre una rivoluzione. A volte è un passo piccolo, silenzioso.
È quando ti iscrivi a un corso, ma ci vai da sola e con il cuore che batte. È quando decidi che no, oggi non rispondo subito al telefono perché vuoi stare un po’ con te.
È quando metti il rossetto rosso anche se non hai un appuntamento, ma ti piaci così.
È un nuovo inizio che non fa clamore… ma ti cambia.
Credevo che a una certa età le “sorprese” si limitassero alle bollette. Poi ho scoperto che esistono ancora cose di me che non conoscevo: una parte più ironica, più creativa, più testarda, ma anche più tenera.
Scrivendo, disegnando, ascoltando chi mi sta vicino, mi sono accorta che dentro di me c’è ancora una ragazza curiosa.
Un po’ stanca, va bene… ma ancora viva, viva davvero.
E allora oggi cammino senza fretta. Non ho bisogno di sapere sempre dove sto andando.
Mi basta sapere che ci sono. Con tutte le mie incoerenze, i miei entusiasmi, le mie partenze improvvise.
E se qualcuno mi chiede:
— "Ma tu adesso, che fai?"
Rispondo:
— "Mi reinvento."
Come si fa con una vecchia sedia: la ridipingi, la metti sotto il sole… e ci trovi una nuova vista.

Oggi mi sono svegliata presto. Non perché dovevo fare qualcosa, ma perché volevo godermi quel momento raro e prezioso in cui il mondo dorme ancora… e io no.
Il fresco del mattino, l’aria leggera, il silenzio pieno di possibilità. Un tempo avrei detto: “Non ho niente da fare.”
Ora dico: “Ho tutto questo tempo da vivere.”
Mi sono preparata il caffè. E poi, come una bambina con un giocattolo nuovo, mi sono seduta davanti al mio computer.
Sì, il computer. Quell’aggeggio che per molti della mia età è ancora un mistero, o peggio: un nemico. Eppure, io lo trovo meraviglioso. È una porta, una finestra, una macchina del tempo. Ti fa viaggiare, ricordare, scrivere, esplorare.
Ti collega, ti stimola, ti tiene viva.
Per fortuna, abbiamo una nave spaziale a portata di mano.
Se solo alle persone anziane venisse insegnato davvero, con dolcezza e pazienza, a usare un computer, il mondo cambierebbe forma. Ci sarebbero meno giornate vuote. Meno silenzi pesanti. Più finestre aperte. Internet può sembrare freddo. Ma dipende da cosa ci cerchi.
Può anche essere una carezza. Un album di foto. Una lettera. Un video di un concerto del ’74 che ti fa brillare gli occhi.
Può essere una seconda possibilità: per imparare, per scrivere la propria storia, per dire "ci sono anch’io".
Io oggi, davanti allo schermo, non mi annoio più. Navigo, leggo, scrivo.
E mi dico: magari ci fosse arrivata anche mia madre. Lei che amava raccontare, scrivere poesie in dialetto, ridere con le parole…
Chissà quante cose avrebbe potuto regalare anche al mondo digitale.
E invece oggi tocca a me.
Scrivere è diventato il mio modo di esserci. Non solo per raccontare agli altri… ma per raccontare a me stessa. Scrivere mi cura.
Mi calma, mi illumina. Mi rimette a fuoco.
Anche se nessuno leggesse, io lo farei comunque. Perché mi serve. Come respirare. Come camminare scalza sull’erba.
Come il primo sorso di caffè quando tutto tace.
A volte basta poco per stare bene. Un sabato tutto per sé. Una tastiera che aspetta. Una mattina che comincia piano.
Un pensiero che si fa parola.
E la sensazione meravigliosa che, nonostante tutto, la vita continui a sorprenderti.

la Rina (mia mamma) Con gli occhi pieni di nostalgia e il cuore in viaggio, guardava la sua Sardegna sullo schermo… come se potesse accarezzarla con lo sguardo
Ho smesso di guardare la TV.
Non per snobismo o superiorità intellettuale semplicemente per istinto di sopravvivenza.
Ogni telegiornale è una specie di reality show dell’angoscia, una maratona di catastrofi commentate con un ghigno o con la solita voce impostata.
Ci dicono cosa pensare, chi odiare, quando tremare.
Io, grazie, ho già dato.
Ho vissuto guerre (anche dentro casa), epidemie (di paura, più che di virus), e ingiustizie che ti scuotono fino allo stomaco. So che l’informazione è importante, ma so anche che la mia sanità mentale lo è un po’ di più.
Cosa penso della guerra? Che è orrenda.


Ma anche che non ho nessun potere per impedirla. E mi dispiace, mi pesa, mi lacera.
Solo che non posso più starmene lì, incollata a uno schermo, a farmi strappare l’anima pezzo per pezzo ogni giorno, sentendomi piccola, inutile, arrabbiata.
A questo punto della vita e me lo sono guadagnato, rivendico il diritto di proteggermi.
Di scegliere cosa entra e cosa resta fuori.
Di coltivare la mia piccola pace quotidiana, anche se il mondo è a pezzi. Non è egoismo. È ecologia dell’anima.
Mi tengo stretta le mattine silenziose, le mani nella terra, i colori, i sorrisi veri, i caffè senza notiziari, i gatti che ignorano la geopolitica.
Non posso cambiare il mondo, ma posso smettere di farmi logorare da ciò che non posso cambiare.
Perciò ho adottato una nuova strategia di sopravvivenza:
Spengo la TV.
Evito i titoloni urlati.
Ignoro gli esperti da salotto.
E accendo la mia coscienza.
Ogni tanto mi aggiornano gli amici:
"Ma non hai sentito? È successa una cosa gravissima!"
Rispondo con calma:
"No. E guarda, ho dormito benissimo."
Attenzione, non sto dicendo che bisogna vivere sotto una campana di vetro.
Il mondo là fuori esiste, e sapere cosa accade può essere utile, persino necessario.
Ma serve distinguere tra sapere e farsi avvelenare, tra essere consapevoli e diventare dipendenti dalla paura.
Nel tempo ho capito che informarsi non è leggere tutto, ma scegliere cosa, come e da chi.
🧭 1. Chiediti: mi serve davvero sapere questa cosa?
Una notizia che mi cambia la giornata in peggio e non posso farci nulla... forse non è informazione, è intrattenimento tragico.
(E io preferisco guardare i tramonti, se devo piangere.)
🔍 2. Segui fonti diverse, non sempre le stesse.
Se tutti dicono la stessa cosa con le stesse parole... è sospetto.
Io alterno voci: leggere, profonde, critiche, ironiche, poetiche. Alcune persino mute (i libri, che parlano ma non urlano).
👣 3. Osserva le emozioni che ti lascia una notizia.
Se ti senti stanco, frustrato, piccolo, colpevole, agitato... forse è il momento di spegnere e uscire a prendere un po’ d’aria.
A volte la mente si disintossica meglio al mercato che in salotto.
🌱 4. Coltiva la tua realtà quotidiana.
Il mondo ha bisogno di persone lucide, non di spugne che assorbono panico.
Informarsi con consapevolezza significa anche restare presenti a sé stessi, alle relazioni, alle piccole cose che funzionano.
Che poi sono quelle che ti salvano, sempre.
📚 5. Ricorda che non sapere tutto… va benissimo.
Non siamo enciclopedie. Siamo esseri umani.
E se per un giorno non sai cosa è successo nel parlamento lituano o in borsa a Tokyo… sopravviverai. Forse anche meglio.
Informarsi è un atto di libertà, ma anche di amore verso sé stessi.
E oggi, più che essere aggiornati minuto per minuto, abbiamo bisogno di mente fresca, spirito critico e un cuore che batte forte… per ciò che conta davvero.
Io ho scelto la mia via: meno cronaca nera, più cielo azzurro.
Meno panico, più poesia.
E tu?

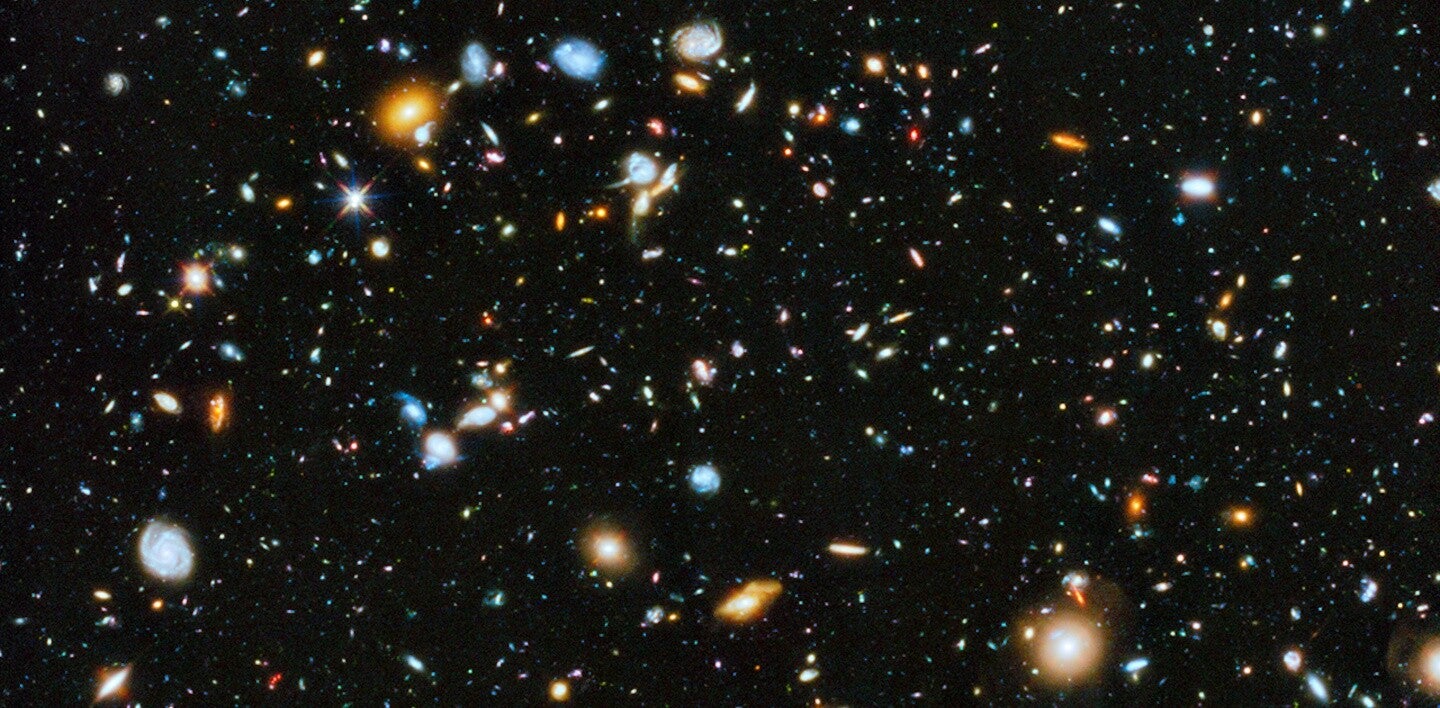
Alessio Barberi, medico e mio caro amico, è uno di quei rari professionisti che non si accontentano di curare i corpi: lui si prende cura anche delle anime, con sensibilità e visione. Nei suoi libri, io sto leggendo "L’antico segreto del mistero della vita”, racconta con sorprendente semplicità un concetto che molti di noi hanno sentito dentro almeno una volta nella vita: la morte non esiste.
No, non è una frase ad effetto. Non è una di quelle consolazioni da cioccolatino. È un'idea potente, radicale, che affonda le radici nella scienza, nella spiritualità e in una visione più ampia dell’esistenza.
Secondo Barberi, tutto ciò che siamo è energia. Non quella poetica, astratta ma proprio energia vera, tangibile, misurabile. Quella che fa battere il cuore, muovere i pensieri, colorare le emozioni. Una “energia cosmica coscienziale”, così la chiama, che non si crea né si distrugge, ma si trasforma, si espande, cambia forma. E quando il corpo finisce, l’energia… continua.


La cosa affascinante è che non si parla solo di sopravvivenza dell’anima in senso religioso, ma di un flusso di energia che non si interrompe mai, come una corrente che da sempre ci attraversa e a cui, alla fine, ritorniamo.. In un certo senso, non siamo mai nati e non moriremo mai, siamo solo apparsi per un po’, con un nome, un volto e una storia da raccontare.
Leggere queste pagine è come sedersi sotto un cielo stellato e sentirsi piccoli, sì… ma anche parte di qualcosa di immenso. Ogni atomo del nostro corpo, lo dicono anche gli astrofisici, è nato in una stella. Ogni battito, ogni sguardo, ogni dolore e ogni gioia, è un frammento dell’universo che prende coscienza di sé.
E allora forse ha ragione Barberi: la morte non è un punto, ma una virgola. Una pausa prima di un nuovo paragrafo.
E se tutto questo è vero, allora anche i nostri cari che non vediamo più… non sono “altrove”. Sono “ovunque”.
Tocca smettere di vivere come se fossimo in scadenza, come lo yogurt.
Tocca riconsiderare tutte quelle ansie da “non ho abbastanza tempo”, “devo fare tutto prima dei 70”, “chissà cosa penseranno di me quando non ci sarò più”.
Spoiler: ci sarai ancora, solo che magari non avrai il Wi-Fi.
Se siamo energia che cambia forma, allora la vita non è un treno che corre verso la fine, ma un gioco di trasformazioni. Una specie di eterno cambio d’abito, dove il vestito cambia, ma lo spirito… resta lo stesso, elegantemente scompigliato.
E a quel punto, anche la morte perde la sua aria tragica.
Non è più “la fine del film”, ma solo una pausa pubblicitaria.
O un cambio scena, di quelli teatrali, in cui gli attori escono, cambiano costume e rientrano da un’altra porta.
Quindi la prossima volta che senti il peso del tempo che passa… ricordati che sei fatto di atomi antichi, sei un riciclo cosmico ben riuscito, e potresti ritrovarti, un giorno, a vibrare nella coda di una cometa. O in una tazzina di caffè. Chi può dirlo?
Mi ero presa una pausa, ma ora basta: chi si ferma è perduto.
E poi, diciamolo: ieri sono nati i miei nipotini! Viggo e .......(anche se… su questo torneremo dopo).
Un’ondata di felicità, di quelle che ti investono all’improvviso come le onde giganti a Marina di Arbus. Avrei voluto gridarlo al mondo, ma mi sono limitata a un post su Facebook: due righe, semplici, pratiche. Un modo per dire: “Ehi amici, è successa una cosa bellissima!”
Non pensavo fosse un gesto da maneggiare con cura.
Mentre mi dirigevo verso l’ospedale con Daniele, arriva un messaggio vocale di Fabio. Tono dolce, ma con un retrogusto di… protocollo infranto.
“Mamma… hai già messo un post? Ci sono delle imprecisioni… forse cambieremo il nome della bambina. E poi… l’annuncio ufficiale volevamo darlo noi.”
E lì, io: pietrificata.
Primo pensiero: ma i miei amici non sono i suoi!
Secondo pensiero: ma io non posso fare quello che voglio?
Terzo pensiero: ok, respira.
Dopo qualche minuto di riflessione e una piccola fitta al cuore, ho scelto di rimuovere il post. Non per senso di colpa, ma per evitare l’ennesimo incidente diplomatico da famiglia emozionata.
In fondo, il mio amore per quei due esserini appena arrivati non ha bisogno di like per essere vero.
Eppure, scriverlo mi aiuta a capire e… anche a non capire del tutto.
Probabilmente ho dimenticato che diventare nonna non significa solo aggiungere un titolo sul curriculum della vita. Significa anche cambiare posto nel cerchio. Un passo indietro, sì, ma con vista privilegiata sul miracolo.
Un po’ come quando a teatro ti sposti in seconda fila: vedi meno le luci, ma meglio le sfumature.
Che la gioia, a volte, va tenuta tra le mani come una tazza bollente: con delicatezza.
Che i figli, anche da grandi, vanno ascoltati con quel silenzio attento che solo le madri conoscono.
E che l’amore vero, quello da nonna, è paziente, discreto… e pieno di foto salvate in bozza, in attesa del via libera.
Nonostante il piccolo inciampo iniziale, è stato un dono poter vedere da vicino quei due esserini meravigliosi. Li ho guardati a lungo, come si osservano le opere d’arte appena nate, cercando somiglianze, espressioni, tracce di famiglia.
E poi… vedere mio figlio, ancora una volta, nella veste di padre. Un uomo che conosco da sempre e che ogni volta mi sorprende.
Ma c’è stato anche un altro momento. Una stretta al cuore.
Proprio in quell’ospedale, quattro anni fa, ho perso mio marito. Entrarci di nuovo è stato come ricevere una sferzata improvvisa.
Il dolore è risalito all’improvviso, senza bussare. Ma si è lasciato trasformare, nella gioia di vedere due nuove vite iniziare.
Come facciamo a contenere emozioni così forti e contrastanti nello stesso respiro?
Quanta è grande la nostra capacità di vivere tutto questo senza spezzarci?
Forse è questo il segreto dell’essere umani: resistere all’urto della vita con il cuore ancora aperto... E, ogni tanto, fare un post ma con il permesso.

Tra lacrime e prime carezze
Come facciamo a contenere emozioni così forti e contrastanti nello stesso respiro?
Mi sono posta questa domanda ieri, mentre osservavo per la prima volta i miei nipotini. Così piccoli, così nuovi… con il loro profumo di latte e di stelle. Li guardavo, e intanto sentivo il nodo alla gola: erano nati nello stesso ospedale in cui, quattro anni fa, se n’era andato Pietro. Lo stesso edificio, lo stesso odore di disinfettante e silenzio, lo stesso corridoio che allora avevo percorso con un dolore che mi spaccava in due.
Eppure... stavolta era diverso. Stavolta il dolore si è fatto da parte. Si è messo in un angolo, umile, come un vecchio compagno che sa che ora tocca alla gioia prendersi la scena.
E così, nello stesso respiro, ho pianto e ho sorriso. Ho sentito la mancanza di chi non c’era e la pienezza di ciò che era appena arrivato. Un paradosso? No. La vita.
Ho capito che il cuore non è una stanza piccola, con una sola sedia. È una casa grande, dove gioia e dolore possono sedersi allo stesso tavolo, anche se non si parlano. A volte si ignorano, a volte si tengono per mano.
E forse è proprio questa la nostra forza segreta: non spezzarci, ma allacciarci. Fare spazio, invece di chiudere. Accogliere anche ciò che fa male, purché non sia tutto.
Un giorno una donna sarda molto anziana, di quelle con la voce che sembra pietra e miele, mi disse:
“La vita è un mare, figlia mia. Ma si deve imparare a galleggiarci anche quando è freddo.”
Ecco, io ora galleggio. Non come una nuotatrice elegante, no… più come un legnetto portato dalla corrente. Ma ci sto. E in questo stare, sento che va bene così.
E allora respiro.
Non per dimenticare,
ma per contenere.
Contenere tutto:
chi se n’è andato,
chi è appena arrivato,
e quel frammento di me
che ha imparato
a non spezzarsi più.
Perché forse non si guarisce mai del tutto.
Ma si fiorisce lo stesso,
anche con le radici nel dolore.
Non è successo in un momento preciso. Nessuna crisi. È più simile a una brezza leggera che ti scompiglia i pensieri mentre stendi i panni, o a una piccola ribellione silenziosa che cresce mentre aspetti in fila alla posta. Un giorno, semplicemente, ho pensato:
"E se uscissi di casa senza cellulare, senza soldi, senza una meta? Solo io, i miei passi, e la fiducia nella vita."
Non per fuggire. Non per dimostrare nulla a nessuno. Solo per vedere se là fuori, da qualche parte, c’è ancora spazio per il contatto umano, per lo scambio vero. Ti lavo i piatti, mi fai dormire sul divano. Ti sistemo il balcone, mi offri un piatto di minestra.
Una specie di pellegrinaggio laico, senza santi né miracoli. Solo un po’ di coraggio, una buona dose di curiosità e un cuore disposto a lasciarsi sorprendere.
Non è il camminare in sé. Non è nemmeno l’avventura. È la voglia di essere più leggera.Di non dover dimostrare, spiegare, correre.
Mi affascina l’idea di vivere per un po’ come si faceva un tempo, quando bastava un gesto, una parola data, un bisogno espresso con onestà. “Io ti aiuto. Tu mi ospiti. Siamo pari.”
Sogno un mondo dove le relazioni valgano più delle transazioni. Dove si possa ancora dire:
"Ho fame, ma anche mani buone."
"Non ho un soldo, ma posso farti ridere, ascoltarti, pulire la tua cucina."
In fondo, è un modo per chiedere alla vita: "Mi accogli così come sono?" Senza filtri, senza status, senza garanzie. Solo io.
Con i miei capelli spettinati, la mia esperienza nelle mani, e la voglia di scambiare storie, non monete. E poi, forse, c’è anche la voglia di fidarmi. Del caso, della gente, di me stessa.
Un piccolo atto rivoluzionario in un mondo dove si controlla tutto, si pianifica tutto, si teme tutto.

Non voglio fare la romantica a tutti i costi.
Lo so che non sarebbe facile. Lo so che potrei trovarmi a dormire sotto un portico o a ricevere sguardi storti.
C’è la paura del freddo, della fame, della solitudine.
Ma quella che pizzica di più è la paura dell’indifferenza. Di bussare a una porta e sentirmi dire:
“No, non abbiamo bisogno.”
Tradotto: “No, non abbiamo bisogno di te.”
Eppure lo so: il rischio c’è. Perché vivere così, senza cellulare, senza soldi, senza appigli, ti mette a nudo. E quando sei nuda, ogni rifiuto fa più male.
Poi c’è anche la paura di perdere il controllo. Di non poter "chiamare qualcuno", "guardare la mappa", "mandare un messaggio".
Noi che siamo diventati i nostri cellulari, come bambini attaccati a un cordone ombelicale di Wi-Fi.
Ma se non si rischia un po’… cosa si vive a fare? Se tutto è sicuro, garantito, previsto… dov’è lo spazio per il miracolo?
Forse la mia paura più grande è un’altra: quella di restare ferma. Di non provarci mai.
Di continuare a fantasticare su un cammino che non inizia mai, mentre la vita passa come un treno che non hai il coraggio di prendere.
Non è solo questione di lavare piatti. È questione di fidarsi. Di me, di te, della vita. Di credere che anche senza un centesimo in tasca, posso ancora essere utile, accolta, viva.
Ogni porta che busserò sarà una domanda:
“Hai ancora spazio per uno scambio umano?”
Non vendo nulla. Non compro nulla. Baratto presenza, gentilezza, storie, mani operose. E in cambio, non chiedo lusso.
Solo un angolo dove stare, una tazza calda, un sorriso non scrollato.
Se questo vi sembra poco, allora tenetevi tutto il resto. Io cammino leggera. E magari, un giorno, ci incontriamo. Tu con la tua casa piena, io con le mani pronte.
E se va bene, scambiamo anche due vite. Solo per una notte. forse nemmeno a “Chi l’ha visto?” saprebbero da dove cominciare.

In cambio, non chiedo niente.
Solo un posto su un camion, un letto nella roulotte, un passaggio verso l’altrove.
Un luogo abbastanza lontano da diventare irraggiungibile.
Credo che lì, nel cuore di quel caos organizzato, tra gli equilibristi e i cavalli ammaestrati, nessuno si accorgerebbe davvero di me.
E anche se qualcuno lo facesse, non mi chiederebbe nulla.
Perché in un circo grande ognuno ha la sua storia – e nessuno ne pretende la versione ufficiale.
Lì potrei sparire con grazia, mescolarmi tra i lustrini e la polvere,
vivere fuori dal radar e dentro una realtà parallela,
dove finalmente non devo spiegare niente a nessuno.
E se un giorno qualcuno provasse a cercarmi...
forse nemmeno a “Chi l’ha visto?” saprebbero da dove cominciare.
Forse non succederà domani.
Ma mi piace immaginare come potrebbe cominciare.
Non con un treno ma con uno zaino sulle spalle.
Con un circo. Grande. Rumoroso. Perfetto per sparire senza dare nell’occhio.
Aspetterei che arrivasse in città, magari di notte, tra luci intermittenti, odore di segatura e vociare di artisti stanchi.
Mi avvicinerei piano, senza troppa fretta, come se fossi sempre appartenuta a quel mondo.
Niente documenti, niente domande, niente spiegazioni. Solo una proposta semplice:
“Posso cucinare per la troupe, dare una mano con i bambini, occuparmi della mensa, pulire, stare zitta se serve o ascoltare se serve ancora di più.”

Alla fine, mi domando: e se la vera ricchezza fosse questa? Camminare leggera. Offrire tempo, ascolto, braccia, in cambio di accoglienza.
Essere utile senza prezzo. Essere libera senza permesso. In un mondo che misura il valore in euro, follower e notifiche…
forse io, con il mio zaino vuoto e la mia voglia piena di vivere, sono la più ricca di tutti.
Perché so chiedere. Perché so dire grazie.
Perché posso guardare negli occhi, senza uno schermo in mezzo.
E perché, se non ho niente… non ho niente da perdere.
Casa della nonna è dove le scatole chiuse diventano bauli di tesori segreti.
Dove ogni oggetto ha una voce, se gliela lasci usare.
I miei ricordi dei nonni e della casa in Sardegna, quella di Guspini
sono ancora vivi come il profumo del pane caldo. E ogni tanto, senza avvisare, tornano a farmi compagnia.
Quella casa l’aveva costruita mio nonno, nei giorni di festa, quando non lavorava nella miniera di Montevecchio.
Era un uomo dalla corporatura esile, scavato più dal lavoro che dagli anni.
Quando sono nata era già in pensione, e si dedicava alla campagna, dove aveva un pezzo di terra: Cuccureba, la chiamavano.
A volte ci portava con lui. Si partiva all’alba, ché il sole d’agosto in Sardegna non perdona.
Lui aveva sempre a tracolla una bisaccia tessuta a mano, bianca e nera, coi disegni tipici della nostra terra.
Dentro: acqua, una merenda semplice e gli attrezzi per potare. La frutta era la vera missione e i fichi d’India, che crescevano come confini viventi lungo i muretti a secco, si raccoglievano con una lunga canna tagliata ad arte, per evitare di riempirsi di spine.

Mio nonno parlava poco in italiano, mischiava le parole, ma noi lo capivamo benissimo. Non ricordo di averlo mai sentito alzare la voce. Con noi, piccoli soldatini, non era necessario.
E poi era dolcissimo, con un senso dell’umorismo irresistibile.
La sera, dopo cena, si sedeva fuori dalla porta a prendere su frìschu, il fresco. Si formavano capannelli di persone che parlavano fino a tardi, e lui raccontava barzellette con quella voce bassa e allegra. Noi bambini giocavamo a giochi che oggi non si usano più, a rincorrere l’estate finché non ci chiamavano per andare a dormire.
La casa dei nonni, io la ricordo grande. O forse ero io a essere piccola. Ma aveva il respiro ampio delle cose fatte col cuore.
Ogni dettaglio era curato: le porte con le cornici lavorate, il pavimento a scacchi bianchi e bordò.
L’ingresso era già una stanza. A destra il salotto buono, che “buono” lo era solo di nome, perché nessuno lo usava mai.
Davanti, la cucina. Un enorme caminetto in granito ne occupava la parete, nero di fuliggine e caldo di ricordi.
Dal retro della cucina si usciva nel cortile, racchiuso da un muro di fango tipico e vissuto. Lì, il limone. Un albero maestoso, carico di frutti gialli in ogni stagione, come se non volesse mai lasciarci a mani vuote.
Lungo il muro c’erano piccole fessure dove spuntavano attrezzi, oggetti strani, cose di cui ignoravo l’utilità ma che osservavo come si guarda un libro chiuso, immaginando cosa ci sia dentro.
E in un angolo del cortile c’era anche una piccola griglia, dove il pesce veniva cotto alla brace, tassativamente irrorato con acqua di mare nessun’altra avrebbe avuto lo stesso sapore.
Un giorno, ricordo una gatta e il suo cucciolo seduti lì vicino. Guardavano in silenzio, senza mai muoversi troppo. Il piccolo, curioso, provava ogni tanto ad avvicinarsi. Ma lei, con una zampetta leggera, lo tratteneva: un gesto pieno di educazione e pazienza, come solo le mamme vere sanno fare.
Sapeva che a tempo debito qualcosa da mangiare sarebbe arrivato anche per loro.
Quella scena mi è rimasta impressa nel cuore. Un piccolo teatro di vita, semplice e perfetto.
Salendo al piano di sopra, tre stanze. Due erano camere da letto, con letti alti e coperte pesanti anche d’estate. La terza era la mia preferita. La stanza della magia.
Lì si mettevano a seccare i pomodori, i fichi, le pere. Il sole entrava in diagonale, il tempo rallentava. E l’aria si impregnava di un profumo che non ho più sentito da nessuna parte.
Un miscuglio dolce, acre, caldo. Mi sdraiavo per terra, a braccia aperte, e respiravo. Forte.
Come per farmi bastare quel momento per sempre.
In un angolo, silenziosa e fiera, c’era una cassapanca antica. Intarsiata a mano con i simboli della Sardegna, profumava di legno e lino.
Un tempo conteneva il corredo delle spose. Ora è nella mia casa. La porto con me, non solo come mobile, ma come ponte tra le epoche, tra chi ero e chi sono diventata.
Ci sono luoghi che ti abitano per sempre. Non servono fotografie: basta chiudere gli occhi. E io, ogni tanto, lo faccio. Chiudo gli occhi e torno lì. Nella casa dei nonni, tra il profumo dei fichi secchi, il suono della griglia che sfrigola, e le zampette leggere di una gatta saggia.
E il cuore si rasserena.
Come dopo un temporale estivo.

Qualche giorno fa ho partecipato a una cena per festeggiare una mia amica andata in pensione.
Location da sogno: una villa sulle colline lucchesi, con tramonto da cartolina e prosecco che scorreva come le chiacchiere.
Eravamo un piccolo gruppo, una trentina di persone, e l’età media si aggirava serenamente tra i 65 e i 75. La cosiddetta “terza età”, anche se, a sentir parlare certi medici, sembrerebbe già la quarta.
Lo ammetto: sono arrivata un po’ prevenuta.
Sapevo che avrei trovato persone che normalmente non frequento a parte qualche eccezione affettuosa.
Io, che ho amicizie decisamente più giovani, che mi muovo tra pittura, blog, filosofia e baratti... Che ci facevo lì?
Poi è successo qualcosa. Non saprei dire se sia stato il vino bianco fresco, l’aria sottile di collina o forse quella luce morbida del tramonto, che a volte ammorbidisce anche i giudizi. Fatto sta che, una alla volta, quelle signore “d’altri tempi” hanno cominciato a parlarmi. Non di artrosi o di dentiere (come, lo confesso, temevo un po’), ma di viaggi in Grecia, sogni ricorrenti, nipoti-rivoluzionari corsi di ballo e sport.
E così, senza accorgermene, sono entrata in un mondo sorprendentemente vivo, elegante e gentile. Quelle donne, coi loro capelli d’argento e i foulard di seta, erano belle. Belle davvero. Con una luce negli occhi che non avevo messo in conto. E ho provato, lo dico, una piccola invidia buona. Quella che ti fa dire: “Voglio diventare così anch’io.”
Un’altra cosa strana: alcune facce mi sembravano familiari. Da quando sono tornata a vivere a Lucca, mi capita spesso. È una città che, anche quando non ti parla, ti guarda. Magari non ci si conosce, ma ci si è visti mille volte: al Liceo Artistico, al supermercato, in fila dal fornaio o seduti su una panchina a chiacchierare con una sconosciuta che ti chiama “tesoro”.
Ed ecco che anche a quella cena, pian piano, emergevano connessioni sottili:
“Tu sei la sorella di…”
“Ma lo sai che ho lavorato con tua cugina?”
“Ti ricordi quella festa nel '78? C’era anche lui!”
E lì ho capito.
Ci sono fili invisibili che ci legano, anche se non si vedono subito. Fili sottili come la seta, ma resistenti. Magari non ci vestiamo allo stesso modo, non ascoltiamo la stessa musica, non ci seguiamo su Instagram (anzi, alcune pensano ancora che sia un tipo di carta da forno)… Eppure ci ritroviamo a ridere della stessa battuta, o a commuoverci per la stessa storia. Come se il tempo, alla fine, non contasse poi così tanto. Uno di quei fili si è teso forte quando una di loro ha detto:
“Da giovani pensavamo di cambiare il mondo… ora ci accontentiamo di cambiare i cuscini del divano. Ma la grinta è rimasta.”
Mi è sembrata una dichiarazione d’amore alla vita, anche con qualche ruga in più. Così, tra una fetta di crostata e un brindisi, mi sono ritrovata a sentirmi parte. Senza sforzi, senza forzature, senza dover spiegare nulla.
Perché, in fondo, non sono l’età o gli interessi a decidere chi ci somiglia davvero, ma la voglia di condividere qualcosa di vero.
Senza filtri.

La ragazza che sono stata vive ancora dentro di me.
Non è mai andata via, nonostante gli anni, le rughe, le scelte, e quelle strade che non avevo previsto di percorrere. È lì, silenziosa, con gli occhi spalancati come davanti a un cielo nuovo, piena di meraviglia e di speranza.
La sento quando l’odore della pioggia mi riporta a un pomeriggio lontano, quando bastava un arcobaleno per credere che tutto fosse possibile. La sento quando un sogno bussa, anche timido, e io resto lì a chiedermi se valga la pena inseguirlo. Lei lo sa: vale sempre la pena.
Stamani, la mia amica Donatella mi ha fatto un regalo prezioso: mi ha letto una lettera che le avevo scritto nell’agosto del 1973, dalla Sardegna. Un reperto quasi archeologico, sopravvissuto al tempo e alle vite che abbiamo attraversato. Avevo diciannove anni e la scrittura correva a penna, imperfetta ma vera, senza correzioni veloci né emoticon a mascherare le emozioni. Parole nate lente, a mano, che oggi posso rileggere e sentire ancora vive.


Se allora avessi mandato un messaggio dal telefono, quelle righe si sarebbero perse per sempre, inghiottite nel buio di qualche chat dimenticata. Invece sono lì, incise su un foglio che profuma ancora di giovinezza, di sale e vento di mare.
Quella vacanza era a Pistis, un angolo di Sardegna che allora era davvero fuori dal mondo. Non c’era niente, eppure c’era tutto: il sole che ti vestiva di luce, il mare che decideva il ritmo delle giornate, il silenzio che sapeva farsi compagnia. La sera, il buio era vero buio, e il cielo si riempiva di stelle come se volesse parlarti.
Rileggendo quelle parole di una me diciannovenne, ho riconosciuto la voce della bambina che porto ancora dentro: la stessa che si stupiva per un tramonto, che credeva che ogni incontro avesse un senso, che pensava che la vita fosse un’avventura da attraversare a piedi nudi.
Forse non potrò esaudire tutti i suoi desideri, ma almeno uno sì: continuare a guardare il mondo con occhi curiosi, pronti a lasciarsi stupire. Perché crescere non vuol dire spegnere la meraviglia, ma imparare a custodirla… e magari, ogni tanto, lasciarla parlare.
E forse ora dirò qualcosa che suonerà fuori moda… o, come direbbero i più giovani, “da anziana”.
Ma credo che dovremmo tornare a scrivere lettere. Di qualsiasi tipo: d’amore, prima di tutto, ma anche di ringraziamento, di scuse, o solo per dire “ti penso”.
Ho nostalgia di quando il postino non era un anonimo consegnatore di bollette e multe, ma un vero personaggio: il messaggero che portava notizie, belle o brutte che fossero. Il suono della sua bicicletta o del motorino era un piccolo evento: un collegamento diretto con chi stava lontano.
Certo, oggi il tempo è la cosa che consideriamo più preziosa. Tutto deve essere veloce, immediato, “visto e ricevuto”. Ma forse è proprio dal tempo che dovremmo ripartire: rallentare, lasciare che le parole si depositino sulla carta come gocce di pioggia su un vetro, che abbiano il tempo di trovare la loro forma e il loro peso.
Una lettera non è solo comunicazione: è un oggetto vivo, che puoi toccare, rileggere, tenere tra le mani anche anni dopo. Un messaggio su WhatsApp sparisce in un attimo, ma una lettera può sorprenderti dopo mezzo secolo, come un biglietto lasciato sotto la sabbia e ritrovato per caso.
Scrivere a mano è un atto di presenza, quasi un piccolo dono di sé. E forse è proprio questo che oggi ci manca di più.

Quando i miei nipoti hanno iniziato a frequentare una scuola privata che adottava il metodo Montessori, lo confesso: ero dubbiosa.
Mi chiedevo se fosse davvero efficace o se fosse soltanto una moda pedagogica per genitori un po’ alternativi.
Con il tempo, però, ho dovuto ricredermi. Ho visto con i miei occhi bambini più felici, curiosi, pronti a scoprire il mondo. Non era un apprendimento imposto, ma desiderato: non la noia di pagine da mandare a memoria, ma la gioia di scoprire, sperimentare, mettere le mani nella vita.
Il metodo Montessori non è libertà senza regole, come qualcuno superficialmente pensa, ma un modo diverso di concepire la crescita: non insegnare al bambino, ma con il bambino.
Maria Montessori, medico e pedagogista, fu una pioniera straordinaria. Credeva che ogni bambino custodisse dentro di sé una forza naturale, un desiderio innato di apprendere. Per questo il suo metodo si basa su alcuni principi semplici ma rivoluzionari:
Autonomia: lasciare che il bambino faccia da sé, sviluppando fiducia e responsabilità.
Ambiente preparato: aule organizzate con materiali accessibili, che stimolano concentrazione e curiosità.
Apprendimento attivo: non nozioni astratte, ma esperienze pratiche che coinvolgono mani, mente e cuore.
Rispetto dei tempi individuali: ogni bambino cresce con il proprio ritmo, senza paragoni forzati né classifiche.
I risultati sono sorprendenti: bambini disciplinati senza bisogno di imposizioni rigide, capaci di collaborare, attenti agli altri e desiderosi di imparare.
Oggi mio nipote Giona ha quasi 13 anni. Non sogna un telefonino, la sua grande passione è la storia, e se vuole un regalo chiede un libro. Forse non è un miracolo, ma io credo che ci sia dentro molto del seme piantato da quell’esperienza montessoriana.
Ed ecco che nasce una domanda inevitabile: perché mai un metodo così efficace rimane confinato alle scuole private?
Le ragioni sono tante, e nessuna soddisfacente.
Il Montessori richiede materiali particolari e spazi dedicati, che costano più delle aule tradizionali. Pretende insegnanti formati a un approccio nuovo, osservatori pazienti più che “trasmettitori di programmi”. Chiede libertà dai rigidi schemi ministeriali, dai voti, dalle verifiche standardizzate. Tutto questo mal si sposa con una scuola pubblica spesso ingessata, povera di risorse e più attenta a mantenere l’ordine che a coltivare talenti.
Eppure, in Italia patria di Maria Montessori non dovremmo accontentarci di vederne applicata la filosofia in poche scuole private, accessibili solo a chi può permetterselo. Esistono anche scuole pubbliche montessoriane, è vero, ma sono rare, quasi delle oasi nate dalla tenacia di insegnanti e genitori.
Io credo che la Montessori non volesse creare un’élite, ma donare a tutti i bambini un’educazione che li rendesse liberi, responsabili, appassionati di conoscenza.
Forse il problema non è il metodo, ma la nostra paura del cambiamento.
Perché a volte sembra più facile difendere un sistema che non funziona che avere il coraggio di piantarne uno nuovo.
Eppure basterebbe osservare i bambini: loro sanno insegnarci che imparare è la più grande avventura della vita.
Se la scuola ha paura del cambiamento, allora dovremmo ricordarle che il futuro appartiene ai bambini, non ai programmi ministeriali


Se i bambini di oggi, i futuri uomini e donne di domani, crescessero tutti con il metodo Montessori, il mondo avrebbe un volto diverso.
Avremmo adulti più collaborativi e meno competitivi, capaci di assumersi responsabilità, curiosi, creativi e rispettosi dei tempi altrui. Sarebbero persone più autentiche, meno ossessionate dalle apparenze e dalle etichette, più centrate sulla persona che sul giudizio.
Non sarebbe un mondo perfetto, ma certamente un mondo abitato da individui che hanno imparato a pensare con la propria testa e a sentire con il proprio cuore.
E qui il dubbio sorge spontaneo: non sarà che è proprio questo il problema?
Il mio dubbio non è affatto ingenuo. Forse è molto più “conveniente” crescere bambini abituati all’obbedienza cieca, alla competizione, alla dipendenza da regole imposte dall’alto. Perché un bambino che impara ad ubbidire sarà un adulto che segue, non uno che mette in discussione.
Maria Montessori voleva formare uomini e donne liberi, non sudditi obbedienti. E forse è proprio per questo che il suo metodo non è mai stato davvero adottato su larga scala.
La verità è che la scuola sa benissimo che il metodo funziona. La vera domanda è: siamo pronti ad accettare una generazione che pensa con la propria testa?
Io credo che come società non siamo ancora pronti.
Perché una generazione che pensa con la propria testa sarebbe più libera, più creativa, più difficile da controllare. E il potere che sia politico, economico o sociale, ha sempre preferito cittadini docili, che obbediscono, piuttosto che individui critici che fanno domande scomode.
Eppure… credo anche che abbiamo un bisogno vitale di questa generazione.
Il mondo di oggi, con le sue crisi ambientali, sociali, economiche, non si può affrontare con menti addomesticate. Ci servono persone capaci di inventare, di mettere in dubbio, di immaginare strade nuove.
Quindi no, non siamo pronti.
Ma se vogliamo un futuro migliore, dobbiamo diventarlo.
E forse proprio i bambini con la loro naturalezza, con la loro curiosità instancabile, potrebbero insegnarci ad esserlo.


T
Oggi è domenica. Questa mattina ho fatto un salto in un discount vicino casa ed è stato un momento piacevole. Mi sono resa conto di una cosa lampante: ogni supermercato ha la sua clientela, o meglio, ogni supermercato attira persone con personalità diverse.
Quello di stamani, l’Eurospin, mi ha confermato una sensazione: la gente più semplice e umile è anche la più piacevole, comunicativa e predisposta al rapporto umano. Sono stata dentro non più di mezz’ora e in quel tempo ho parlato con ben quattro persone.
Al reparto pane e dolci, una signora ed io ci siamo scambiate opinioni sui vari tipi di pane; davanti allo scaffale degli articoli per animali, un signore mi ha dato un consiglio prezioso; in fila alla cassa, una signora si rimproverava di comprare troppi dolci proprio come faccio anch’io di solito e ci siamo messe a ridere insieme. Infine, un gentilissimo signore mi ha fatto passare avanti, e da lì è nata un’inaspettata conversazione sul fatto che ormai ci sono più stranieri che italiani, ricordando come la nostra generazione, fino ai vent’anni, non avesse mai visto dal vivo né una persona di colore né una orientale.
E, per concludere, la cassiera che mi ha accolto con un sorriso.
Piccole cose, forse, ma sono quelle che rendono una semplice spesa della domenica mattina un momento di umanità che ti riconcilia col mondo.
Viviamo in un tempo che corre, spesso senza guardarsi indietro. La tecnologia scandisce le nostre giornate, gli impegni ci inseguono, e il rumore di fondo della società ci avvolge al punto che rischiamo di dimenticare la cosa più semplice e più rivoluzionaria: la nostra umanità.
A volte sembra quasi che ci sia più facilità nel dividersi che nel unirsi, più prontezza nel giudicare che nel comprendere. Basta accendere la televisione o scorrere un social per trovarsi di fronte a conflitti, parole dure, notizie che allontanano invece di avvicinare. In questo clima, un gesto gentile diventa un atto di coraggio.
La riconciliazione con il mondo non è un concetto astratto. È il bisogno profondo che ciascuno di noi porta dentro: quello di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di ritrovare il filo invisibile che ci lega agli altri e alla natura. Ci riconciliamo con il mondo quando riusciamo a riconoscere l’altro come un essere umano prima che come “ruolo”, “categoria”, o “etichetta”.
Un momento di umanità può nascere ovunque: in una corsia di supermercato, in un autobus affollato, o davanti a un caffè condiviso. Sono attimi semplici, che non fanno notizia ma che hanno la forza di cambiare la giornata di qualcuno e forse, goccia dopo goccia, il mondo intero.
Non servono grandi proclami, bastano piccole azioni:
Un sorriso rivolto a uno sconosciuto che sembra avere una giornata difficile.
Una parola gentile invece di un rimprovero affrettato.
Una mano tesa senza chiedere nulla in cambio.
Un ascolto vero, senza il filtro del giudizio.
Sono gesti che sembrano insignificanti, ma che hanno un potere disarmante. In un mondo abituato alla durezza, alla fretta, alla competizione, la gentilezza è un atto rivoluzionario.
Non possiamo però riconciliarci con il mondo se non impariamo prima a riconciliarci con noi stessi. Significa accettare le nostre fragilità, guardare con compassione i nostri errori, smettere di rincorrere modelli di perfezione che non ci appartengono. Quando smettiamo di essere in guerra con noi stessi, ci diventa più naturale abbassare le armi anche verso gli altri.
Abbiamo bisogno, tutti, di rallentare e di ritagliare questi momenti. Non si tratta di utopia, ma di sopravvivenza emotiva. Perché senza umanità, il mondo diventa un meccanismo vuoto; con l’umanità, anche il dolore trova un senso e la gioia diventa condivisa.
E allora proviamo, ogni giorno, a regalarci e a regalare un piccolo frammento di umanità. Forse non cambieremo il mondo intero, ma sicuramente cambieremo il nostro modo di viverlo.

La condizione di essere persone, con i nostri limiti e grandezze, è ciò che ci rende profondamente umani. Non siamo fatti di perfezione, ma di contrasti: slanci di amore e improvvise cadute, fedeltà che durano una vita e promesse infrante in un attimo. È in questa fragile danza che si inserisce il tradimento, ombra inevitabile dell’essere umano.
Tradire significa varcare una soglia: può essere un gesto consapevole o un inciampo involontario, un atto verso l’altro o verso noi stessi. Perché non si tradiscono solo amori e amicizie, ma anche valori, sogni, persino la propria dignità. Eppure, paradossalmente, il tradimento non è solo distruzione: spesso diventa uno specchio che ci obbliga a guardare chi siamo davvero, a confrontarci con i nostri limiti e a riscoprire se vogliamo la grandezza che credevamo perduta.
Il tradimento non è solo la fine di una storia o di una fiducia: è un terremoto che ci spinge, nostro malgrado, davanti allo specchio. E non è uno specchio gentile, di quelli che trovi nei camerini con la luce perfetta: no, è uno specchio spietato, che ti restituisce rughe, stanchezza e verità. Ti costringe a chiederti chi sei davvero, al di là dei ruoli che hai recitato o delle illusioni che ti eri cucito addosso.
In quel riflesso non vediamo soltanto la mano che ci ha ferito, ma soprattutto i nostri limiti, le nostre ingenuità, le aspettative che – forse – erano castelli costruiti sulla sabbia. E allora il tradimento diventa un maestro: brutale, non richiesto, ma efficace.
Certo, all’inizio ci sembra di aver perso tutto. Poi, piano piano, ci accorgiamo che non era proprio “tutto”: quello che cade a terra sono le impalcature, ma noi restiamo in piedi. E se siamo abbastanza ostinati (o testardi, dipende dal punto di vista), scopriamo che proprio lì, tra i cocci, si nasconde una nuova possibilità: quella di riscoprire la nostra grandezza, non quella da statue di marmo, ma quella semplice e umana di chi sa rialzarsi.
Il tradimento, insomma, è una palestra di vita. Non l’avremmo mai scelto come corso extracurricolare, ma già che ci siamo iscritti a forza… tanto vale uscirne con qualche muscolo in più.

Io vivo nella mia casa delle bambole.
Non quella di cartone e stoffa che avevo a dieci anni, ma la sua eco adulta, proiettata nello spazio reale. Una casa grande, silenziosa, in cui posso muovermi da una stanza all’altra come facevo allora, quando i miei passi si traducevano nei gesti di Susanna, la mia bambola.
Allora le affidavo il compito di vivere al posto mio: la facevo camminare, cenare, addormentarsi in quella piccola scenografia, immaginando che un giorno io stessa avrei avuto una casa tutta mia, e il tempo come un bene da amministrare con libertà, minuto dopo minuto, giorno e notte.
Oggi, a distanza di anni, mi sorprendo a scoprire che quel gioco era una profezia.
La mia vita è diventata davvero una casa delle bambole: più grande, certo, ma non meno fragile. Qui mi sposto, riempio le ore con i medesimi movimenti, a volte rassicuranti, a volte ripetitivi come una nenia che non smette mai. È come vivere dentro una matriosca: dentro ogni stanza trovo la bambina che ero, che gioca a immaginare la donna che sarei stata. E dentro quella donna, ora, riconosco di nuovo la bambina.
La vita, forse, non procede in linea retta: si avvolge a spirale, ritorna, ci mette davanti i nostri stessi sogni, trasformati in realtà.
E allora mi chiedo: quante delle cose che viviamo oggi erano già scritte nei nostri giochi d’infanzia? Quanto del nostro presente è in realtà una ripetizione sacra, un rituale che ci tiene legati a quella che siamo stati?
Io, ogni giorno, abito questa casa-matriosca.
E mentre mi muovo tra corridoi e stanze, sento che in fondo non ho mai smesso di giocare.

Nell’essere umano c’è sempre una ricerca incessante: la felicità. A volte la inseguiamo nelle grandi imprese, altre nelle piccole gioie quotidiane. Ma se guardiamo bene, il filo conduttore che lega ogni nostro passo è il gioco.
Non parlo solo del gioco infantile, fatto di bambole, costruzioni o corse in cortile. Quel gioco era l’allenamento alla vita: ci insegnava a inventare mondi, a interpretare ruoli, a sognare un futuro. Dentro quella leggerezza, dentro quelle risate, c’era già tutto: speranza, amore, desiderio di libertà.
Poi cresciamo e crediamo di abbandonarlo, ma in realtà continuiamo a rincorrerlo sotto altre forme. Giochiamo con le possibilità quando prendiamo una decisione, giochiamo con i sogni quando immaginiamo nuove strade, giochiamo persino con i sentimenti, quando ci lasciamo sorprendere dall’amore o ci buttiamo in un’avventura senza sapere come andrà a finire.
Il gioco è la conferma che siamo vivi. È ciò che ci impedisce di diventare rigidi, chiusi, spenti. È la nostra capacità di non prenderci troppo sul serio, di sorridere di noi stessi, di rialzarci dopo una caduta e dire: “ancora una volta, ricominciamo”.
Forse la felicità non è un traguardo lontano, ma la possibilità di vivere la vita come un gioco eterno: con leggerezza, curiosità, stupore. E ogni volta che ritroviamo questa attitudine, anche solo per un istante, sentiamo che il cuore si apre e che la vita, ancora una volta, scorre dentro di noi.


Quando il dialogo diventa un comizio, il silenzio e un sorriso sono la mia forma di libertà
“Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.”
Questa frase, attribuita spesso a Voltaire, per me è l’essenza stessa della democrazia.
Eppure, quante volte mi capita di ritrovarmi in situazioni in cui la conversazione smette di essere un confronto per trasformarsi in un comizio. Io sarei assolutamente aperta allo scambio di idee, al dialogo sincero, ma dall’altra parte trovo spesso qualcuno che non ascolta: pontifica, sentenzia, e magari pretende anche che io annuisca.
In quei momenti ho imparato a proteggermi. Non mi arrabbio più, non alzo la voce, non cerco di convincere nessuno. Mi limito a piccoli movimenti con la testa, a un sorriso leggero. Intanto, nella mia mente, può anche scorrere la lista della spesa: “uova, pane, latte, verdure…”. È questione di allenamento e, soprattutto, di rispetto per me stessa.
Il momento più sgradevole arriva quando qualcuno tenta di farti sentire un’idiota solo perché non la pensi come lui. Ma a 71 anni questo non può più accadere. Ho imparato che il vero segno di maturità è proprio questo: non dover vincere ogni discussione, non dover convincere nessuno, non dover difendere la mia intelligenza davanti a chi non vuole capire.
Difendere il diritto di parola non significa subire passivamente chi urla più forte. Significa avere la forza di restare se stessi, senza lasciarsi ingabbiare. E, a volte, significa saper sorridere anche mentre pensi al banco frigo del supermercato.
Forse dovremmo ricordarlo tutti: le idee non si impongono, si condividono. Un dialogo vero non è fatto di muri, ma di ponti. E se oggi imparassimo ad ascoltare un po’ di più, senza il bisogno di avere sempre ragione, scopriremmo che la diversità di pensiero non è una minaccia, ma un arricchimento.
E questo è il mio augurio a chi legge: imparate a custodire la vostra voce e a rispettare quella degli altri. Perché nella libertà di parola non c’è solo la democrazia: c’è la bellezza di restare umani.

l silenzio non è vuoto.
Non è assenza, mancanza o rinuncia.
Il silenzio è spazio. Uno spazio che può curare, proteggere, nutrire.
Nella nostra società il silenzio viene spesso frainteso: lo si confonde con la debolezza, con il non avere argomenti, con il cedere terreno. Ma chi lo ha imparato davvero sa che non c’è niente di più potente del tacere al momento giusto.
Il silenzio non sempre è ritiro: può essere scelta. Una forma di rispetto per sé e, a volte, anche per l’altro. Perché non tutte le parole meritano una risposta, e non tutte le discussioni hanno bisogno di un vincitore.
Ho capito col tempo che il silenzio è una forza che ti salva dall’inutile. Ti libera dall’urgenza di spiegare, di convincere, di dimostrare. Ti regala quella leggerezza che arriva quando smetti di lottare contro chi non vuole ascoltare.
Eppure il silenzio non è sempre facile: richiede allenamento, come un muscolo che va esercitato. All’inizio sembra impossibile non ribattere, non dire la propria, non lasciarsi trascinare dal vortice. Poi, piano piano, diventa naturale: un sorriso leggero, un respiro profondo, e il pensiero che corre altrove – magari alle piccole cose quotidiane, come la lista della spesa.
Il silenzio non è resa. È protezione. È la capacità di scegliere le proprie battaglie e, soprattutto, di non sprecare energie dove non germoglierà nulla. È un modo di restare interi, quando le parole degli altri cercano di spezzarci.
Ed è anche un dono. Perché nel silenzio possiamo ascoltarci davvero: i nostri pensieri, le nostre emozioni, persino i sussurri della vita che, nel rumore, non sentiremmo mai.
Considero il silenzio un alleato. Mi ha insegnato che non serve sempre una risposta per avere dignità. Che non serve sempre alzare la voce per essere forti. E che, a volte, la vera vittoria è proprio quella di restare in pace con sé stessi, senza dover dire nulla.

Ieri pomeriggio ho fatto una lunga chiacchierata con due testimoni di Geova.
A pensarci bene, credo di essermi fermata con loro perché avevo dipinto dalla mattina presto ed ero stanca: sentivo il bisogno di sedermi e scambiare due parole con qualcuno. E loro, di argomenti, ne hanno un’intera Bibbia da analizzare, parola per parola.
I discorsi si sono aperti a ventaglio, toccando mille sfaccettature della vita. Una vera palestra per i miei neuroni: ascoltare, rispondere, mettere in dubbio, confrontare. Non importa se alla fine non condivido tutto, ciò che resta è l’esercizio di pensiero, la curiosità, l’allenamento della mente.
Improvvisamente mi è venuta in mente mia madre. Negli ultimi anni viveva da sola, sempre con il cellulare a portata di mano. Nei momenti di vuoto chiamava parenti lontani, noi figli e perfino amicizie di mezzo secolo che non aveva mai perso, grazie al telefono. E quando le capitavano le solite chiamate dei call center, io le raccomandavo:
«Mamma, se vedi numeri sconosciuti attacca, o meglio, non rispondere!»
Lei, con quel suo modo un po’ ironico, replicava:
«E perché non dovrei rispondere? Almeno faccio due chiacchiere!»
Allora mi sembrava una bizzarria, oggi la capisco benissimo. Ci sono momenti in cui anche un “disturbo” può trasformarsi in un’opportunità: una piccola finestra aperta sugli altri, un frammento di vita altrui che entra nella nostra.
Forse è proprio questo che mi gratifica: il rapporto con le persone. Ogni incontro, anche casuale, è un nutrimento. Ogni persona custodisce qualcosa che io non ho, e io lo assorbo, lo accolgo, lo faccio mio. Un po’ come un vampiro che non succhia sangue, ma storie, pensieri, esperienze.
E alla fine, mi accorgo che non sono io a rubare, ma la vita che mi regala.

Cosa spinge un essere umano a dedicare la propria vita a una religione che impone regole rigidissime?
A rinunciare a piaceri semplici, a occasioni di gioia, a possibilità che la vita stessa offre, pur di seguire un libro scritto secoli e secoli fa?
Per me è sempre stato un enigma. Perché se c’è una regola che riconosco come universale è una sola, semplice e chiara: non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te stesso.
Il resto – divieti, imposizioni, precetti – non rischia forse di diventare una gabbia costruita dall’uomo per l’uomo?
E poi, diciamolo: chi ci assicura che sia la Bibbia la verità? O il Corano? O qualsiasi altro testo sacro? Non saranno piuttosto tentativi diversi di raccontare lo stesso mistero, ognuno a modo suo, ognuno con i propri limiti, ognuno plasmato dal tempo e dalla cultura in cui è nato?
Forse la religione è un bisogno umano più che una verità assoluta: ci serve per dare un senso al caos, per sentirci parte di qualcosa di più grande, per avere un binario su cui camminare quando la libertà ci spaventa. Ma quanto costa questo bisogno? Non è forse contronatura privarsi di esperienze che non fanno male a nessuno, se non in nome di un codice scritto da altri?
Io non ho risposte definitive, e diffido di chi dice di averle.
Oggi ho fatto un’esperienza incredibile. Un amico mi ha regalato delle uova appena raccolte dalle sue galline, freschissime, non più tardi di stamani. Non ho resistito: sono corsa a casa e ne ho assaggiata una come faceva mia mamma quando ero bambina, con zucchero e limone, direttamente nel cucchiaio.
Un sapore unico, pieno, vero. Mi ha riportata indietro di quarant’anni in un istante, come una macchina del tempo racchiusa in un guscio fragile. Mi sono chiesta: cosa è successo da allora? Perché un semplice uovo oggi non ha più quel gusto?
La risposta è sotto i nostri occhi: manipolazioni, allevamenti intensivi, mangimi industriali. Abbiamo trasformato l’alimento più naturale e basilare in qualcosa di anonimo, impoverito, standardizzato. E ci siamo abituati a credere che sia normale.


Eppure il cibo non è solo nutrimento. È cultura, è tradizione, è memoria. È il legame con la terra, con chi lo produce, con la nostra stessa storia. Alterarlo significa alterare anche noi stessi. E allora mi domando: quali conseguenze ha tutto questo sul nostro organismo, sulla nostra salute, sulla nostra capacità di distinguere il vero dal finto?
Viviamo in un mondo che ha paura di tutto, e che pure non si accorge di ciò che distrugge davvero la nostra essenza. Ci vietano di avere galline o conigli in giardino, parlano di eliminare le mucche perché producono metano, e intanto ci ammaliamo di malattie che prima non conoscevamo.
Forse la soluzione non è semplice, ma una via esiste: recuperare la saggezza di un tempo, scegliere il cibo vero, sostenere chi produce con amore e rispetto. Non si tratta di tornare indietro, ma di camminare avanti portandoci dietro quello che non andava dimenticato.
Un uovo oggi mi ha insegnato che il sapore del passato può ancora salvarci il futuro.

Ogni settembre si ripete il rito: zaini nuovi, quaderni profumati di carta fresca, campanelle che segnano il ritorno alla routine. L’inizio della scuola porta con sé entusiasmo, paure e aspettative. Ma dietro questa immagine rassicurante, c’è una verità che raramente viene detta: la scuola non è mai stata un luogo neutrale.
Fin dalle sue origini, l’istruzione è stata uno strumento di potere. È servita a formare cittadini obbedienti, soldati disciplinati, lavoratori efficienti. A seconda delle epoche e dei regimi, i programmi scolastici sono stati piegati a interessi politici, religiosi o economici. Non è un mistero: la scuola è anche un veicolo di manipolazione culturale.
Eppure, proprio per questo, lo studio resta fondamentale. Perché non si tratta solo di “imparare quello che c’è scritto nei libri”, ma di allenare il pensiero critico, di imparare a distinguere tra ciò che ci viene detto e ciò che è davvero. Saper leggere, scrivere, contare, conoscere la storia e la filosofia, ci rende capaci di riconoscere i tentativi di condizionamento.
La scuola ci fornisce gli strumenti: sta a noi usarli con libertà.
Non basta studiare per avere bei voti, bisogna ragionare con la propria testa. Bisogna avere il coraggio di fare domande, di dubitare, di non accettare verità imposte. Solo così lo studio diventa un atto di libertà e non una catena dorata.
Ai ragazzi che oggi ricominciano il loro cammino, auguro di avere fame di conoscenza, ma anche il coraggio del dubbio. Perché sapere è potere, ma pensare è libertà.
Così la penso io, con la mia testa e con il mio cuore. Artemisia
Non parlo del dolore fisico quello che, per quanto atroce, arriva a un punto finale: si muore una volta sola.
Il dolore di cui voglio parlare oggi è un altro: quello dell’anima, quello che non ti lascia morire ma continua a farti a pezzi, ogni volta un po’ di più.
È come una porta di vetro che si frantuma: puoi cercare di ripararla, incollare le schegge, trovare un modo per conviverci. Ma basta un urto improvviso, qualcuno che ci sbatte contro, e i frammenti tornano a volare dappertutto. E ogni volta, la ferita sembra più profonda, più crudele.
Ti chiedi: perché io?
Ti sembra una punizione, una condanna che non hai meritato.
Cos’è che fa più male? L’indifferenza? La mancanza di amore? L’essere dimenticati? Forse tutto insieme.
E poi c’è un’altra ferita: quella di dover nascondere il dolore agli altri, di fingere serenità, perfino felicità, solo per non sopportare il peso della loro compassione. È una recita stancante, che lascia l’anima ancora più sola e più fragile.
Il dolore dell’anima è così: non ti permette nemmeno il lusso di morire. Ti lascia viva, ma spezzata.
E allora come si sopravvive?
A volte con piccoli respiri, cercando solo di non affogare. A volte con ricordi che scaldano, con la speranza, fragile e ostinata, che domani possa esserci una luce diversa.
Sopravvivere significa questo: riconoscere il dolore, dargli un nome, ma non lasciargli l’ultima parola.
Ci sono momenti in cui basta un fiore che sboccia sul balcone, una risata improvvisa, un pensiero gentile che arriva da chi non ti aspettavi. In quei momenti capisci che nonostante tutto, tra le crepe del vetro, filtra ancora luce.

Per anni io e mio marito abbiamo lavorato nel settore della depurazione, un mondo tecnico e concreto, dove impari presto che dietro le cifre e le dichiarazioni ufficiali ci sono sempre dinamiche meno limpide. Già allora, osservando i meccanismi della gestione ambientale, i dubbi ci venivano chiari. Oggi, di fronte alla narrazione trionfale sulla raccolta differenziata, quei dubbi sono diventati rabbia.
Ci ripetono che a Lucca abbiamo raggiunto l’81% di raccolta differenziata. È un dato che ci riempie di orgoglio, ci fa sentire cittadini virtuosi. Ma cosa significa davvero?
Significa soltanto che l’81% dei rifiuti è stato separato dai cittadini nei vari bidoni. Non significa che l’81% sia stato davvero riciclato.
E qui si apre la zona d’ombra.


Scarti inevitabili: una parte consistente del materiale differenziato è contaminato, sporco o mescolato male. Anche se lo buttiamo nel sacco giusto, può diventare rifiuto indifferenziato durante la selezione. Gli scarti possono arrivare al 20-30%.
Plastica difficile: solo alcune plastiche (come il PET delle bottiglie) hanno un vero mercato di riciclo. Le plastiche miste finiscono spesso in “plasmix” (panchine, arredi urbani), che non sono infinite volte riciclabili, oppure vengono incenerite per produrre energia.
Il Tetrapak: ci dicono che si ricicla. In parte è vero: la fibra di carta viene recuperata. Ma plastica e alluminio, nella maggior parte dei casi, diventano scarti o materiali secondari di bassa qualità.
Percentuali gonfiate: nei report ufficiali i materiali vengono considerati “riciclati” già quando lasciano l’impianto di selezione (ad esempio Revet a Pontedera) e vengono mandati ai consorzi. Ma nessuno ci dice quanti, a valle, vengano davvero trasformati in nuovi prodotti e quanti vengano scartati di nuovo.
Il cittadino crede di fare il proprio dovere, e lo fa. Ma i rifiuti non sono solo un problema ambientale: sono un business miliardario.
Ogni tonnellata raccolta, selezionata e spedita genera contributi, incentivi, pagamenti dai consorzi. L’importante è “muovere tonnellate”, non sempre garantire che quelle tonnellate diventino nuova materia prima.
Dietro ci sono appalti, monopoli territoriali, lobby industriali. La plastica vergine, prodotta dal petrolio, costa poco. Il riciclo, invece, costa molto. Capite bene che spesso è più conveniente parlare di riciclo che farlo davvero.
Perché scaricare tutto sulle spalle del cittadino?
Noi possiamo differenziare con cura, ma se a monte ci danno imballaggi impossibili da riciclare, il gioco è truccato. Multistrati, poliaccoppiati, plastica e alluminio fusi insieme: prodotti “usa e getta” che nascono già come rifiuti senza futuro.
La vera rivoluzione sarebbe vietare gli imballaggi misti e imporre materiali semplici, riciclabili al 100% come vetro, alluminio, carta. Materiali che rinascono infinite volte. In molti Paesi europei esiste già il vuoto a rendere: bottiglie che tornano al produttore e vengono riutilizzate. Perché da noi no?

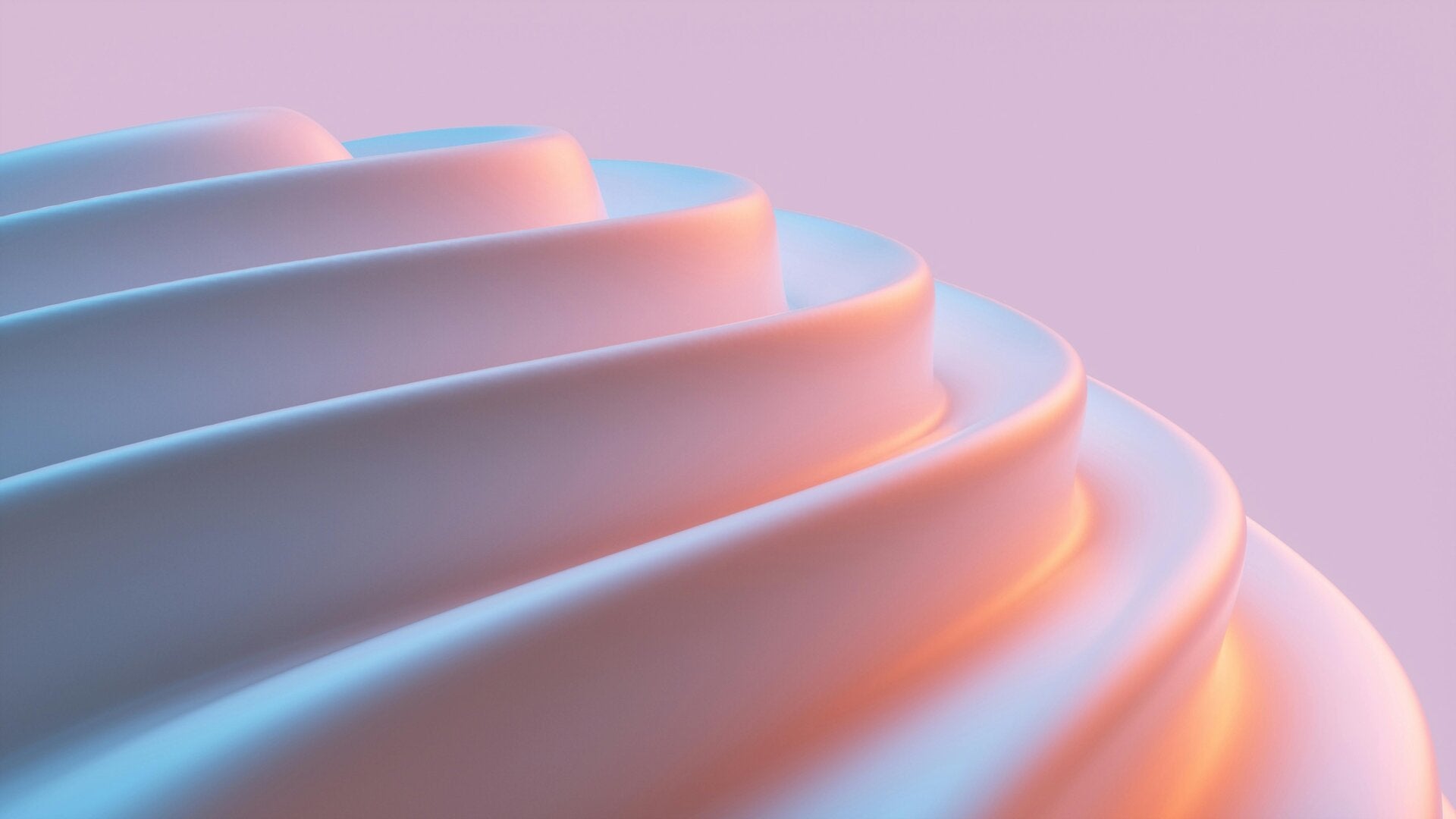
Forse morirò senza vedere questo problema risolto. Ma quello che chiedo, e che chiedo a nome di tanti cittadini, è almeno trasparenza.
Non voglio sentir parlare solo di “percentuali record di raccolta differenziata”. Voglio sapere: quanti di quei materiali sono davvero tornati a nuova vita? E quanti sono finiti in discarica, inceneritore o in qualche stiva diretta all’estero?
Perché quando manca la trasparenza, e quando la comunicazione è solo propaganda, nell’aria si sente inevitabilmente odore di truffa.
Alcuni incontri non appartengono al tempo,
ma a un luogo segreto del cuore,
dove chi amiamo non smette mai di parlarci.
Giovedì scorso sono partita per Querceta con un nodo nel cuore. Non sapevo bene perché lo facessi, ma sentivo che dovevo andare. Forse cercavo un segno, forse solo un po’ di pace.
Lungo la strada, gli alberi autunnali mi accompagnavano come antichi amici.
Le foglie cadevano leggere, e in quell’oro sospeso tra cielo e terra mi sembrava di leggere un messaggio: niente finisce davvero.Il cielo era velato, ma non triste.
Aveva quel colore di perla che preannuncia la quiete, e io, nel silenzio del viaggio, parlavo a Pietro come facevo un tempo:
“Se puoi, fammi capire che ci sei ancora. Anche solo per un attimo.”
La casa era semplice, quasi anonima. Una porta chiara, un piccolo giardino, nessuna insegna.
All’interno, una stanza ordinata e luminosa: due sedie, un tavolo, una lampada accesa.
Niente incensi, niente cristalli, nessuna atmosfera da mistero. Solo silenzio, e una sensazione di calma che sembrava respirare insieme a me.
Lei è apparsa così, come fosse sempre stata lì.
Una donna sui cinquant’anni, o forse poco più, il viso sereno, i gesti lenti. Vestita in modo semplice, quasi invisibile, ma con una luce gentile negli occhi. Mi ha abbracciata senza dire nulla, e in quell’abbraccio ho sentito qualcosa sciogliersi il dolore, la nostalgia, la paura che tutto fosse davvero finito.
Mi ha fatto sedere e mi ha chiesto di scrivere il nome di Pietro. Ho preso la penna con mano tremante.
Le lettere sembravano vive, come se ogni curva avesse ancora la sua voce.
Lei ha passato la mano sopra al foglio, e il silenzio è diventato più denso, quasi sacro. Poi ha iniziato a parlare.
La voce, a tratti, cambiava sfumatura come se venisse da un luogo diverso, più lontano e più vero.
— Stefano… chi è Stefano?
— Mio fratello — ho risposto.
Lei ha chiuso gli occhi.
— Pietro dice che deve fermarsi, che la salute viene prima di tutto. Che non può più portare tutto quel peso.
Le parole mi hanno attraversata come un’onda calda e fredda insieme. Perché sì, Stefano è stanco, e da tempo non sta bene davvero.
Poi, dopo un breve silenzio, ha domandato:
— Maria… chi è Maria?
— È la compagna di mio figlio.
Lei ha sospirato piano, poi con voce quasi paterna ha detto:
— Pietro non è sereno. Dice che non è la persona giusta per lui.
Non ho risposto. Non avevo bisogno di farlo. In quel momento, mi bastava sentire.
Poi, con una dolcezza infinita, la sua voce si è fatta tenera:
— Sto bene, non sento più dolore. Sono con il mio babbo. Mi piace la foto che hai messo di noi due.
Le lacrime sono scese senza rumore. Lei sorrideva, e ogni tanto mi porgeva un fazzoletto, dicendo sottovoce che anche per lei questi incontri erano un dono.
“Mi riempiono di pace,” ha sussurrato, “come se una piccola parte di cielo si aprisse ogni volta.”
Quando sono uscita, il tramonto stendeva un velo rosato sulle colline.
Mi ha parlato di molte altre cose e ogni cosa mi ha fatto emozionare e rimanere stupita.
L’aria sapeva di terra bagnata e di legna accesa, e io mi sentivo più leggera, come se qualcuno mi avesse tolto un peso dal cuore.
Non so spiegare cosa sia accaduto davvero. Non voglio nemmeno provarci. So solo che da quel giorno ho smesso di cercare prove: mi basta la sensazione che Pietro sia ancora con me.
Che mi accompagni nei piccoli gesti, nelle luci della sera, nei sogni in cui torno a sentirne la voce.
Perché so che l’amore non muore: cambia solo forma, diventa aria, luce, presenza. E ci sfiora, silenzioso, ogni volta che il cuore è pronto ad ascoltare.
Aggiungi commento
Commenti